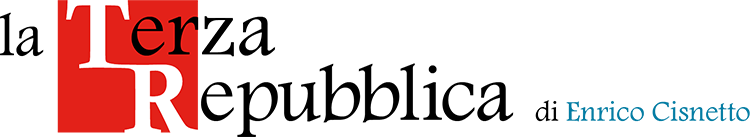La manovra e il bipopulismo
LA MANOVRA DEGLI PESUDO RICCHI RIFLETTE L’ESSENZA DEL BIPOPULISMO: LIMITI CULTURALI A DESTRA, TABÙ IDEOLOGICI A SINISTRA
di Enrico Cisnetto - 15 novembre 2025
Una esecrabile pantomima. Lo scontro politico-mediatico che è andato in scena sulla manovra “che favorisce i ricchi”, oltre che surreale, racchiude in sé tra i peggiori difetti di questo disgraziato Paese: dai tabù e le ipocrisie sulla ricchezza che albergano a sinistra, al vittimismo dei governanti che non sanno neppure difendere quelle (poche) scelte giuste che fanno, passando per la capacità tutta italica di montare un polverone sul niente. Così, mentre l’economia italiana si accinge a crescere solo di mezzo punto (se tutto andrà bene) nonostante la spinta del Pnrr, senza la quale saremmo in piena recessione, confermando una tendenza che viene da lontano – dalla grande crisi del 2008 ad oggi abbiamo avuto 6 anni di recessione e 6 di stagnazione, mentre dal 1946 al 2007 ci furono soltanto due momenti di arretramento del pil (1975 lo shock petrolifero, 1993 la crisi monetaria) – di fronte ad una legge di bilancio caratterizzata dalla prudenza ma non certo dal coraggio, ecco che il nostro bipopulismo, con l’immancabile corollario mediatico a supporto, ci sforna due piatti uno più immangiabile dell’altro.
Il primo è quello del governo. Presenta una manovra povera, light nei numeri e priva di ambizione programmatica: 18,3 miliardi al confronto di una spesa pubblica attestata sui 1200 miliardi, un pil di poco superiore ai 2mila miliardi e un debito ormai oltre i 3mila miliardi, è niente. Non disarticola le compatibilità finanziarie, non fa fare un passo avanti alla crescita. Ma anziché limitarsi a rivendicare il non contestabile vantaggio di contenere il deficit e mettere il Paese nelle condizioni di poter uscire dalla procedura d’infrazione Ue in cui eravamo incappati, aggiunge una bugia da naso lungo – “l’economia sta andando bene” – e una litania – “le difficoltà sono colpa dei provvedimenti dei governi precedenti, a cominciare dal superbonus” – inascoltabile visto che siamo al terzo anno di uno degli esecutivi più longevi della Repubblica e alla quarta legge di bilancio. Poi succede che in alcune audizioni parlamentari di primarie istituzioni, a cominciare dalla Banca d’Italia, venga sottolineato, senza alcun accento critico né tantomeno polemico, che quel poco di manovra fiscale che c’è si rivolge al ceto medio e non alle fasce di reddito più basse, oggetto degli interventi precedenti. Una pura constatazione, che il governo avrebbe dovuto rivendicare. Invece, di fronte alla distorcente lettura secondo cui la manovra premierebbe i ricchi a discapito delle categorie più fragili, il ministro Giorgetti, forse risentendo del clima “vannaccizzato” che si respira nel suo partito, se ne esce dichiarandosi addirittura “massacrato” da “coloro che hanno il potere di farlo”. Una presunta criminalizzazione subito avvallata dalla presidente del Consiglio, che non tralascia occasione per attaccare “i nemici”, alimentando un’insopportabile contrapposizione da campagna elettorale permanente che non solo fa male al Paese, ma che, anche a volerla vedere speculativamente, alla lunga non avvantaggia nessuno.
Il secondo piatto avvelenato è quello sfornato dalla sinistra. Il giudizio sulla manovra è banale e monco. Non una parola sulla precarietà e anomalia delle coperture – per metà arrivano da risorse del Pnrr dirottate e dalla “spremitura” delle banche che, come dice Veronica De Romanis nella War Room di mercoledì 12 novembre (qui il link), configura una inaccettabile “tassazione ad personam” – una generica rivendicazione di misure per la crescita, senza avanzare una proposta che una, ma soprattutto la rivendicazione di una maggiore e diversa redistribuzione del reddito, facendo finta che sia prodotto (cosa che non è) e senza indicare una sola voce di spesa da tagliare. L’unica cosa che il campo largo – Cgil compresa – ha saputo dire è che questa manovra rappresenta “un salasso per le famiglie per aiutare i ricchi”. Critica cui si è aggiunta la consueta idea di una patrimoniale sui milionari, senza peraltro specificarne le soglie. Peccato che la definizione “ricchi” sia stata usata in relazione alle fasce di reddito superiori a 45 mila euro lordi, su cui si concentra l’85% delle (poche) risorse mobilitate dal taglio Irpef, cioè chi guadagna circa 2400 euro netti al mese, e che i due terzi di quelle risorse riguardi chi sta sotto i 50 mila euro lordi. Insomma, puro pauperismo ideologico: è scattato il solito riflesso condizionato ideologico sulla ricchezza, che crea invidia e rancore sociale, del tutto sganciato dalla realtà, visto che le chiavi di lettura per capire chi è ricco e chi non lo è cambiano costantemente. Mutui, affitti, figli a carico, uno o più stipendi in famiglia, costo della vita nelle grandi città: i fattori da cui deriva una valutazione completa della soglia di benessere – che è cosa diversa dalla ricchezza – sono tanti e mutevoli. Indicare una cifra univoca è quindi demagogico, tanto facile a livello propagandistico quanto forzato sotto il profilo politico. Anche perché il tema retributivo è realmente urgente, e meriterebbe di essere affrontato organicamente, considerato che le retribuzioni annue lorde degli italiani sono mediamente inferiori rispetto al 2008 dell’8,7%, il potere di acquisto si è eroso di 10 punti percentuali negli ultimi 5 anni e che la spesa delle famiglie ancora alla fine del 2024 era minore dell’1,4% a quella precedente alla grande crisi finanziaria di 17 anni fa.
Ed è proprio la classe media, in tante delle sue molteplici articolazioni, ad aver pagato il prezzo più alto, in questi anni. E non è solo una questione di reddito. Come ha ricordato il direttore generale del Censis, Massimiliano Valerii, nella War Room di cui sopra, è il processo di “cetomedizzazione” della società italiana, iniziato con il boom economico del dopoguerra e durato fino agli anni Novanta, ad essersi inceppato. Significa l’impossibilità di soddisfare le proprie aspirazioni, il mancato funzionamento dell’ascensore sociale, la sfiducia che i figli possano avere condizioni di vita migliori o perlomeno eguali a quelle dei genitori. A questo aggiungeteci il progressivo venir meno, perché finanziariamente insostenibile, del “welfare generoso” del secolo scorso (pensioni e sanità) e il declino demografico – caratterizzato da un calo delle nascite, un invecchiamento della popolazione e una sua riduzione complessiva, non sufficientemente compensata dall’afflusso dell’immigrazione – e avrete il quadro di una società vecchia, ferma e depressa. Che tende a consumare il patrimonio accumulato nei decenni delle vacche grasse, senza impegnarsi a produrre nuova ricchezza. E infatti è conservatrice, perché tende a mantenere lo status quo, è corporativa, perché rivendica la tutela dei piccoli e grandi privilegi castali, ed è allergica al progresso scientifico e in generale all’innovazione, come dimostra il dibattito pubblico sull’intelligenza artificiale, tutto teso a evocarne i possibili pericoli invece che studiarne le prorompenti potenzialità applicative (segnalo di sfuggita, ma ci tornerò presto sopra, che uno degli economisti più pessimisti, Nouriel Roubini, che nel 2006 aveva anticipato l’arrivo della catastrofe finanziaria e ancora due anni fa preconizzava un collasso mondiale provocato dall’eccesso di debiti, ora sostiene che la rivoluzione tech ci regalerà un boom secolare).
Da qui l’indisponibilità a concedere il consenso a quelle scelte che potrebbero rimettere in moto la macchina dello sviluppo e, di conseguenza, riattivare il processo di “cetomedizzazione” che per mezzo secolo aveva fatto grande l’Italia. Sono quelli che Angelo Panebianco chiama gli “orientamenti profondi” del Paese. Mi riferisco alla tendenza a pretendere sostegni, bonus, sgravi, gratuità anziché preferire gli investimenti strategici e sistemici, inserita nella più ampia inclinazione a preferire la rendita al profitto; all’indifferenza verso la qualità dei sistemi formativi, da cui dipende la capacità di adattarsi ai cambiamenti tecnologici e la preparazione di personale qualificato per il sistema produttivo; alla scarsa propensione a creare le condizioni per dispiegare le energie dello sviluppo, dall’affrancare le imprese da un eccesso di vincoli e oneri impropri all’apertura alla concorrenza e liberalizzazione dei mercati, compreso quello del lavoro. Tutte tendenze – racchiudibili nella più complessiva predilezione a consumare il presente piuttosto che a scommettere sul futuro – che la politica, negli ultimi trent’anni, ha assecondato se non incrementato, essendosi predisposta a vellicare gli istinti sociali anziché guidare la società, orientandola verso le scelte più opportune.
La manovra di bilancio, e più in generale l’orientamento della politica economica (quel poco che si è fatto e si fa), sono lo specchio fedele di questa tendenza. La destra al governo, dovendo produrre come massimo sforzo l’archiviazione delle proprie cattive idee (con le quali ha vinto le elezioni, si badi) tanto da conquistare elogi proporzionali al tasso di incoerenza dimostrata, si è affidata alla politica della conservazione, cui ha dato il nome di stabilità per nobilitarla, anche se la declinazione più corretta è immobilismo. Da qui leggi di bilancio (non solo quest’ultima) puri esercizi d’ordine, prudenti ma povere, non solo e non tanto nei numeri quanto nella valenza strategica, affidate esclusivamente alla leva fiscale, l’unico strumento cui si mette mano nella cassetta degli attrezzi di governo. Nessuna visione, nessuna scelta strutturale. Fino al punto di mettere nero su bianco (nel documento programmatico di finanza pubblica redatto dal Tesoro e fatto proprio dal governo) che nei prossimi anni rimarrà piatta la produttività totale dei fattori, cioè l’indicatore che misura l’attrattività di un sistema economico (pubblica amministrazione funzionante, giustizia efficiente, libertà di fare impresa).
Sul fronte opposto, la sinistra, anziché usare un coraggioso linguaggio di verità e offrire un’alternativa basata sul pragmatismo, si è attrezzata a fare un’opposizione puramente rivendicativa, demagogica, intrisa di tabù ideologici e parole d’ordine d’antan. Un vuoto culturale riempito dai decibel delle polemiche e dalla convocazione di scioperi generali ad esclusiva valenza politica. Nessuna analisi, nessuna elaborazione, solo indignazione, buona per un consenso tanto al chilo. Così l’opposizione contribuisce in egual misura alla maggioranza di governo a far sì che i privilegi, quelli veri, restino tali, e le fragilità, quelle reali e non quelle fotografate dalle rilevazioni fiscali sui redditi che non tengono conto dei patrimoni e della composizione familiare della platea dei contribuenti – tanto che il 40% dei lavoratori guadagna meno di 15 mila euro e contribuisce per il solo 1% al gettito – non trovano conforto, anche perché ci si affida a una miriade di interventini sintomatici anziché mettere in campo terapie sistemiche.
È questo il bipopulismo italiano: scontro tra opposti sul passato, comune immobilismo nel presente, seppure recitato con copioni diversi, e totale assenza di futuro. Continuare a tenerlo in vita e riproporlo, facendo leva sulle ragioni – minuscole – che di volta in volta possono far preferire l’uno o l’altro fronte, è suicida, perché sempre di populismo si tratta. È venuto il momento di smontarlo, questo sistema perverso. Come? Ne parliamo diffusamente la prossima settimana. (e.cisnetto@terzarepubblica.it)
L'EDITORIALE
DI TERZA REPUBBLICA
Terza Repubblica è il quotidiano online fondato e diretto da Enrico Cisnetto nato nel 2005 dall'esperienza di Società Aperta con l'obiettivo di creare uno spazio di commento indipendente e fuori dal coro sul contesto politico-economico del paese.