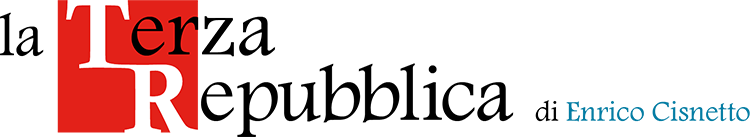L'effetto Trump e la difesa della nostra libertà
DALLA TREGUA PRECARIA DI GAZA VENDUTA COME “PACE ETERNA” ALLA TORSIONE DELLA DEMOCRAZIA USA VERSO UN’AUTOCRAZIA ELETTIVA
di Enrico Cisnetto - 18 ottobre 2025
Sulla “nuova alba per l’intero Medio Oriente” enfaticamente promessa da Donald Trump si sono già addensate inquietanti nuvole nere. Hamas che torna a presidiare il territorio, giustiziando in piazza i nemici, Israele che rallenta l’accesso degli aiuti umanitari, gli Stati Uniti che reclamano il disarmo immediato dei terroristi pena la reazione militare di Tel Aviv. Altro che la “pace eterna” ricercata da “3000 anni”, frettolosamente data per acquisita dal presidente americano negli incredibili show cui ha dato vita, in Israele e in Egitto, per sancire e celebrare la tregua di Gaza. Non si tratta di sottovalutare la portata dell’accordo raggiunto a due anni dal maledetto 7 ottobre 2023, che quantomeno ha momentaneamente messo fine ai massacri, né di sminuire il ruolo che in esso hanno avuto Trump e i suoi negoziatori. Né di essere pessimisti, anche se è noto che il Medio Oriente è un cimitero pieno di accordi di pace e, come ha scritto David Sanger sul Times, il piano di Trump rischia di essere l’ennesima “pausa temporanea in una guerra iniziata molto prima della fondazione di Israele nel 1948 e mai finita”. Si tratta di essere realisti: retorica (la pace eterna non esiste) e photo opportunities sono cattive consigliere, rischiano di creare false aspettative, di favorire ambiguità, di impedire una chiara visione dei problemi e l’individuazione delle soluzioni. Da questo punto di vista, gli scenografici appuntamenti di Gerusalemme e Sharm el-Sheikh, in cui il presidente americano si è preso tutta la scena esibendo una postura debordante quasi fosse il padrone di casa e pronunciando zuccherosi discorsi autocelebrativi, sono l’esatto opposto di quello che davvero serve per avviare un serio processo di costruzione della pace. Non ne faccio una questione di buon gusto e di opportunità al cospetto di decine di migliaia di morti – che pure… – ma di sostanza: trasformare un passaggio della vicenda mediorientale certamente significativo dal punto di vista diplomatico e politico in una kermesse trionfalistica non aiuta a far tacere ulteriormente le armi al di là del primo cessate il fuoco. Anzi. E le reciproche minacce dei contendenti che sono subito partite, lo confermano.
Insomma, se si vuole passare davvero dalla tregua scenografica alla pace, vera e duratura, è sì necessario legittimare il successo di Trump – sono stolti coloro che per avversione alla sua figura, minimizzano – ma nello stesso tempo è indispensabile analizzare i limiti dell’accordo tra Israele e Hamas tradotto nel patto firmato dai 4 paesi negoziatori (Usa, Egitto, Turchia e Qatar). Esercizio indispensabile per avviare quanto prima la fase 2, quella più complessa, che mira a stabilizzare il Medio Oriente trovando un equilibrio non precario tra Israele e Palestina. Cisgiordania compresa. Il campo è minato da molte insidie: dal disarmo di Hamas alla governance della Striscia fino alla sua ricostruzione, dalla definizione dello Stato di Palestina all’evolversi della situazione politica in Israele. Già il primo ostacolo appare quello più difficile da superare: se Hamas decide di resistere, come purtroppo sembra essere, rischia di venir meno anche il contingente multinazionale guidato da Paesi arabi e musulmani che dovrebbe garantire la sicurezza dell’area, e di conseguenza verrebbe meno il ritiro israeliano e il cessate il fuoco. A quel punto, del piano di pace trumpiano resterebbe ben poco (per saperne di più, vedi la War Room di martedì 14 ottobre, qui il link).
Non sono un pacifista a senso unico e non mi scandalizza l’uso massiccio della “diplomazia della forza” – una guerra non si ferma con i confetti – ma invece mi preoccupa, e molto, l’ostentazione muscolare – tanto più se unita all’esaltazione della ricchezza, come ha ripetutamente fatto Trump nelle sue performance teatrali – perché impedisce alla politica di subentrare alla forza, per tornare a far valere il diritto internazionale e il dialogo. C’è un tempo per l’una e un tempo per l’altra cosa, confonderle è grave ed è tipico di chi accusa una forte dipendenza “dalla droga del potere”, per dirla con le parole di uno che The Donald lo conosce molto bene, il suo ex direttore della comunicazione (lo è stato durante il primo mandato presidenziale), Anthony Scaramucci. Secondo lui il Trump che fuma “il crack del potere” è sempre più incoraggiato dalla mancanza di conseguenze per le sue mosse audaci perché sulla scena internazionale molti leader stanno “cedendo” alla sua debordante personalità, con poche eccezioni, come per esempio il primo ministro canadese Mark Carney (non a caso assente a Sharm el-Sheikh). È quanto sostiene anche un vecchio saggio come Rino Formica, secondo cui nel colonialismo imperiale trumpiano non c’è spazio per la cultura della complessità, che nello specifico significherebbe prendere atto della provvisorietà delle intese e gestirla avendo in mente un percorso progressivo – per esempio rinnovando le classi dirigenti – in mancanza del quale sarà inevitabile che la guerra torni, presto, a insanguinare quei territori.
Stando così le cose, non solo si è autorizzati a domandarsi se l’eccessiva personalizzazione della “pace made in Trump” mediorientale rappresenti un problema per quella tormentata vicenda – storia che rischia di ripetersi nello scenario russo-ucraino – ma è pure lecito chiedersi se gli Stati Uniti d’America siano ancora un paese pienamente democratico. Lo so, la domanda appare provocatoria, ma è legittimata dalla torsione autoritaria che Trump ha impresso alle istituzioni e alla vita sociale americana. I primi dieci mesi del suo secondo mandato alla Casa Bianca, infatti, sono costellati da uno spaventoso susseguirsi di distorsioni democratiche, attuate su capitoli vitali della vita pubblica, dalla sicurezza alla giustizia, passando per le regole elettorali e le libertà di stampa e satira. Non so se sia corretto, come fa Formica, definire queste distorsioni il “preannuncio di un inedito fascismo”, ma certo metterle in fila fa impressione.
A partire dalle forzature sulla gestione dell’ordine pubblico, che hanno raggiunto livelli di scontro massimi lo scorso giugno, quando Trump fece schierare per le strade di Los Angeles 2 mila soldati della Guardia Nazionale e 700 Marines, con l’obiettivo di sedare le proteste contro i raid anti-immigrati. Un pugno di ferro che ha fatto scalpore, sia perché usato nella più grande metropoli per abitanti di origine straniera, in particolare latino-americani, sia perché molti, a partire dalla sindaca Karen Bass e dal Governatore della California Gavin Newsom, hanno denunciato l’abuso incostituzionale del Presidente, accusandolo di autoritarismo, anche per l’aggressività dei metodi utilizzati dai soldati e la spettacolarizzazione di arresti ed espulsioni, molte delle quali bloccate successivamente dai tribunali. Secondo gli osservatori più acuti – su questo si veda la War Room di giovedì 2 ottobre, qui il link – Los Angeles potrebbe rappresentare solo un banco di prova, una sorta di stress test per capire i margini in cui il potere federale può sostituirsi a quello dei singoli Stati sul fronte sicurezza. Anche perché Trump si sta infilando senza remore nelle maglie della Costituzione americana, espandendo poteri che la Carta gli negherebbe.
Un’altra crepa che Trump sta creando nella democrazia americana riguarda l’inesorabile e progressiva marginalizzazione del Congresso, ormai privato della sua potestà legislativa, soppiantata dal decisionismo del Presidente che agisce firmando quotidianamente decreti e ordini esecutivi, con un ritmo superiore 10 volte a quello di Biden e 13 a quello di Obama. Così facendo, Trump sta alterando anche uno dei principi cardine degli Stati Uniti, ovvero il federalismo, accentrando in capo all’amministrazione federale molte competenze statali. Ma c’è di più. Personalmente mi inquieta il quotidiano elenco di atti presidenziali che vanno a ledere lo stato di diritto, ad alterare l’equilibrio dei poteri, a mortificare lo spirito oltre che la lettera della democrazia. Qualche esempio? Giustizia usata per combattere nemici e cancellare violazioni proprie o degli amici, tanto che il relativo ministero è stato ribattezzato “Dipartimento della Vendetta”; stampa e satira imbavagliate (secondo Trump dovrebbero avere “licenza di trasmettere” solo se megafoni del verbo Maga); zero rispetto del principio della divisione dei poteri.
E ancora, il tycoon sta cercando di modificare opportunisticamente alcune regole elettorali, come quelle legate alla ridefinizione dei collegi, richiesta espressamente formulata al governatore repubblicano del Texas con l’obiettivo di assegnare il numero massimo di seggi ai repubblicani alle elezioni di Midterm. E così come la California sul fronte sicurezza, in questa torsione il Texas potrebbe fare da apripista, considerato che procedure analoghe di ridefinizione delle mappe elettorali sono in corso in Florida, Indiana, Missouri, Ohio, e in altri Stati guidati dai Repubblicani, ormai totalmente piegati alla volontà del Presidente. Una storpiatura delle regole del gioco democratico che fa il paio con gli ostacoli che la Casa Bianca vuole mettere alle modalità di voto alternative (anticipato e per corrispondenza) tradizionalmente utilizzate maggiormente dall’elettorato democratico, e per questo da contrastare.
E che dire della guerra dichiarata alle Università? Con un drastico taglio dei fondi (si parla di oltre 12 miliardi di dollari) non solo alle élite accademiche come Harvard, ma anche ad una sessantina di vari atenei, tra sforbiciate fatte o per ora solo minacciate. Interventi che si inseriscono in una campagna verso una decisa riduzione della spesa del Dipartimento dell’Educazione, che nel bilancio federale 2025 vale 207 miliardi di dollari, mentre la spesa degli Stati nel settore ha raggiunto i 518 miliardi. Tagli giustificati con ragioni contabili, ma che invece hanno una logica prettamente politica, con la mai nascosta intenzione di togliere spazio alle scuole che diffondono quelle che Trump considera “ideologie radicali e divisive” come quelle liberal-progressiste e della cultura woke, o che contestano apertamente Israele, tanto da indurre il Presidente a bollare niente meno che l’Università di Harvard come un “porto sicuro per l’antisemitismo”.
Poi c’è la guerra ai manager pubblici ritenuti “nemici”: dai ripetuti attacchi al presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al tentativo, poi bloccato da un tribunale, di licenziare Lisa Cook, consigliera della stessa Fed; dalla giubilazione della direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention (si occupano di salute pubblica), a quella di Susan Monarez, colpevole di aver criticato Robert Kennedy Jr, Segretario No Vax alla Salute. E in programma ci sono ulteriori tagli di dipendenti della Pubblica Amministrazione, che Trump rivendica apertamente: “licenzieremo un sacco di gente, saranno Democratici”, ha detto commentando l’avvio dello Shutdown, ovvero la chiusura dei servizi pubblici non considerati essenziali, procedura formalmente dovuta alla mancata approvazione della legge di bilancio da parte del Congresso, ma in realtà coerente con la linea Trump di riduzione di tutto ciò che è “pubblico”, posti di lavoro compresi.
Ho fatto questo lungo, e peraltro non esaustivo, elenco di atti che seguono un palese tentativo di forzare, se non di rompere, l’ordine costituzionale – esasperando i poteri del Presidente e facendo prevalere in modo netto il potere esecutivo su quello giudiziario, con buona pace di Montesquieu e del sacro principio dell’equilibrio dei poteri – per dire che se non si può sostenere che gli Stati Uniti non siano più una democrazia, allo stesso tempo è difficile evitare di definirli avviati verso una forma di autocrazia elettiva, creandole una legittimità teocratica che comporta la distruzione della laicità dello Stato. Si tratta solo di valutare a che punto di questo incredibile processo involutivo l’America sia arrivata, e prendere atto, con buona pace di chi ha detto il contrario, che non avrebbe mai potuto essere insignito del Nobel quando “stai cercando di rovesciare la democrazia che stai rappresentando” (Maureen Dowd sul The New York Times).
Essere consapevoli di tutto questo è un nostro dovere di italiani e di europei, soprattutto se si è sempre stati convinti assertori e difensori della solidarietà euro-atlantica. Il mondo come lo abbiamo concepito e vissuto dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi, sta cambiando radicalmente. Prenderne atto è doloroso, lo so, ma se vogliamo preservare la libertà di cui godiamo e difendere quella altrui, è indispensabile. (e.cisnetto@terzarepubblica.it)
L'EDITORIALE
DI TERZA REPUBBLICA
Terza Repubblica è il quotidiano online fondato e diretto da Enrico Cisnetto nato nel 2005 dall'esperienza di Società Aperta con l'obiettivo di creare uno spazio di commento indipendente e fuori dal coro sul contesto politico-economico del paese.