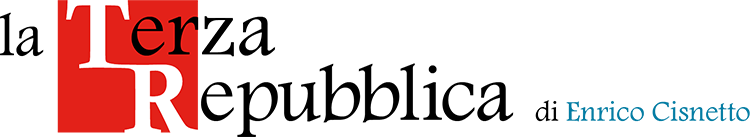Dal paradosso francese una chance per l'Europa
MACRON, DEBOLE IN PATRIA MA CHE GODE DI PRESTIGIO INTERNAZIONALE, LASCI L’ELISEO E SI METTA ALLA TESTA DEI VOLENTEROSI
di Enrico Cisnetto - 11 ottobre 2025
Solo il tempo potrà dare risposta all’angoscioso interrogativo che in queste ore i più assennati si pongono: la tregua a Gaza si trasformerà in vera pace, o si rivelerà solo un’illusoria parentesi che qualcuno – la logica sanguinaria di Hamas, il cinismo di Netanyahu, il pressapochismo di Trump – s’incaricherà di chiudere tra un prima e un dopo di guerra? Nell’attesa, vale la pena di capire se sia fondata la presunzione dei protagonisti italiani delle manifestazioni pro-Pal, molto gettonata dai media, secondo cui la svolta nel conflitto israelo-palestinese sia in buona misura merito loro. Io, pur non sottovalutando la vastità e la portata internazionale dell’ondata di sdegno, sono incline a pensare che non sia così. E non solo per le grandi contraddizioni che hanno riguardato quelle manifestazioni – dalle violenze di gruppi antagonisti agli slogan che celebravano il 7 Ottobre come atto di resistenza e non di terrorismo – ma soprattutto perché si sono mostrate prive di una guida politica, e chi ha avuto la pretesa di metterci il proprio cappello sopra, penso alla Cgil di Landini, non aveva null’altro da offrire se non squadernare un genero sentimento umanitario, che di per sé non poteva trasformare quella moltitudine in un motore di reale cambiamento. Insomma, piazze piene ma senza bussola.
Tuttavia, proviamo per un momento a prendere per buona quella presunzione. Perché, se così fosse, non si capisce per quale motivo quel medesimo sentimento di ripulsa verso la guerra, di pietà verso gli oppressi, non abbia indotto nessuno a manifestare per porre fine alla guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina, che dura da 3 anni e 8 mesi e ha prodotto centinaia di migliaia di morti e feriti e milioni di rifugiati. Per chi coltiva la certezza di aver contribuito alla tregua a Gaza, è una bella responsabilità non aver fatto altrettanto per il martoriato popolo ucraino. La verità è che viviamo immersi nei pregiudizi, nelle alterazioni della realtà, nell’etilismo ideologico. E per questo, da un lato andiamo dietro a credenze che gratificano le nostre coscienze ma sono prive di consistenza e oggettività, e dall’altro perdiamo di vista le cose di cui dovremmo invece occuparci e preoccuparci.
Ma non è una dislessia solo italiana. Temo che ne siano affetti molti altri paesi europei. A cominciare dalla Francia, entrata in un labirinto politico-istituzionale senza precedenti. Dice il mio amico Andrea Bonanni (vedi la War Room dedicata alla crisi politica francese di giovedì 9 ottobre, qui il link) che si tratta di “un paese la cui pancia, irrazionale e perennemente arrabbiata, è cresciuta a dismisura rispetto ad un cervello che si è andato via via indebolendo e che non riesce più a tenere a freno gli istinti autodistruttivi del proprio ventre”. E questo atteggiamento mentale – magari alimentato da una subdola campagna di influenza dell’opinione pubblica architettata da Mosca, aggiungo io – spiega perché dopo aver individuato in Emmanuel Macron l’uomo salvifico che avrebbe risolto la crisi politico-istituzionale aperta anni fa con la fine del duopolio gollisti-socialisti a favore della crescita delle due ali estreme, ora (e da tempo) lo consideri “il problema”, fino al punto da rischiare la disintegrazione del “front républicain”, la diga che storicamente ha impedito all’estremismo di destra e al radicalismo di sinistra di prevalere. Ora, il presidente francese ha delle responsabilità nella crisi politica che minaccia di travolgerlo: non ha impedito che le divisioni e i personalismi spappolassero il centro democratico, non ha saputo creare un asse con l’unica figura politica interessante della sinistra, quel Raphaël Glucksmann (figlio del filosofo André), fondatore di Place Publique ed europarlamentare, che dopo la débâcle del Partito Socialista (guidato da Olivier Faure, attestato sulla linea del “rassemblement de la gauche” e della “sfiducia al governo voluto da Macron”) ha tenuto alta la bandiera riformista evitando di fare il fronte popolare con il massimalista Mélenchon. E da ultimo, avere testardamente riproposto per altre due volte Sebastien Lecornu come primo ministro, dopo che aveva conseguito il triste record del governo più breve della storia transalpina (un giorno), non pare né lungimirante né il mio miglior modo per “evitare la dissoluzione” che lo stesso Macron si è posto come obiettivo. Riaffidare a Lecornu – che ha mestamente accettato “per dovere” – il compito di provare a fare l’ennesimo, e questa volta probabilmente ultimo, tentativo di varare un esecutivo che almeno assicuri l’approvazione della legge di bilancio entro fine anno, appare un atto di debolezza, che tra l’altro rischia di pesare sulla prosecuzione della presidenza Macron.
Tutto questo, però, non toglie che il presidente francese abbia un peso non indifferente e goda di un notevole prestigio sul piano internazionale. Non deve sfuggirci il fatto che in questa tormentata stagione della nostra storia, Macron sia stato e continui ad essere, tra i leader europei, il più tenace sostenitore di Zelensky, il più fiero oppositore di Putin e il più deciso critico di Trump. Inoltre, è colui che più di ogni altro ha riallacciato i fili con Londra, creando un superamento di fatto della Brexit e dando vita insieme al primo ministro britannico Starmer ad un patto tra detentori di armi nucleari che ha portato alla nascita della “coalizione dei Volenterosi”, decisiva dal momento in cui Trump ha gettato a mare 80 anni di solidarietà euro-atlantica. E, per tornare al Medio Oriente, è stato il primo capo di Stato a riconoscere ufficialmente la Palestina come nazione, cosa che ha aperto la strada ad altri 156 paesi (su 193 aderenti all’Onu) che lo hanno imitato.
Insomma, la crisi francese ha fatto emergere un clamoroso (e pericoloso) paradosso che riguarda la figura dell’inquilino dell’Eliseo, che mentre vedeva e vede accresciuto il proprio peso e prestigio sul piano internazionale, perdeva e perde pesantemente consenso sul piano interno. Una contraddizione, sia chiaro, in cui Macron ci ha messo del suo, tanto dal lato dei meriti quanto da quello delle defaillances. Ma che non può essere ignorata, né dai francesi – forze politiche dell’arco costituzionale in testa – né da chi, come noi, osserva quanto accade a Parigi e dovrebbe armarsi di ragionata consapevolezza circa le conseguenze che le labyrinthein cui è finita la Francia, anziché cedere alla infantile pulsione di gioire per le disgrazie altrui (“Macron è spocchioso”, “gli sta bene a quegli sciovinisti che il loro spread sia diventato peggiore del nostro”, e così via).
Ora, una cosa deve esserci chiara: nella crisi francese in ballo c’è qualcosa di più che le pur importanti sorti della Quinta Repubblica francese (che molti, con troppa fretta, eccesso di superficialità e malcelato compiacimento, danno già per morta). Sì, perché la partita transalpina interseca quella che si sta giocando per la ridefinizione degli equilibri geopolitici europei e planetari. Non deve sfuggirci, infatti, che gli opposti estremismi, il Rassemblement National del duo di Le Pen/Bardella e France Insoumise di Mélenchon, convergono – oltre che nel praticare un populismo che vuole impedire la più che ragionevole riforma delle pensioni che innalzi l’età di quiescenza oggi ancora fissata a 62 anni, resa indispensabile dalla condizione dei conti pubblici francesi – nel sostenere un pacifismo peloso che nella pratica condanna ad un tragico destino l’Ucraina. D’altra parte, Le Pen e Mélenchon sono filo-putiniani, e non solo nei fatti (che già basterebbe) ma anche per conclamati rapporti e collegamenti con Mosca.
In altre parole, oggi l’Europa è esposta alla minaccia russa: è resa vulnerabile dall’invasione dell’Ucraina e dalle ulteriori mire del Cremlino verso quei territori che una volta facevano parte dell’Unione Sovietica o ne subivano pesantemente l’influenza (il fu Patto di Varsavia), ed è subdolamente sotto attacco con quella guerra ibrida che Mosca ha lanciato, e che tra le altre cose prevede l’ingerenza nelle vicende interne dei paesi europei – Francia in testa, ma anche l’Italia è un bersaglio grosso – sia “comprando il consenso” di esponenti e forze politiche, sia manipolando le opinioni pubbliche. E se questo è il pericolo a cui siamo (già ora) esposti, non si può non guardare al caso francese valutando quanta influenza Putin abbia esercitato – nel far scoppiare la crisi politica e nell’organizzare e alimentare le proteste sociali – e quanto Macron rappresenti un baluardo a nostra difesa.
Questo, naturalmente, non cancella gli errori commessi dal presidente francese, ma deve spingere tutti a valutare le sue colpe e i suoi difetti in un contesto più appropriato. E, soprattutto, a ragionare su quale sia lo sbocco migliore da dare alla crisi francese. Personalmente, visto che Parigi non sta in un mondo a parte ma è un pilastro essenziale degli equilibri europei, ritengo che Macron dovrebbe sparigliare le carte abbandonando la contesa interna per giocare una partita più grande fuori dalla Francia. Come? Mettendosi alla guida della coalizione dei Volenterosi, dandole una veste più formale e strutturata. Non si tratta di buttare alle ortiche l’Unione Europea, ma di prendere atto che così come è oggi non è in condizione di fronteggiare il pericolo russo né di affrontare le conseguenze della messa in discussione dell’Alleanza Atlantica da parte americana, e di capire che la sua riforma, pur necessaria ovviamente, non può avere i tempi brevi che invece la situazione geopolitica richiede. Dunque, a fianco alla Ue – e della Nato, fintanto che Trump la vorrà in vita – deve sorgere una istituzione che unisca le nazioni europee che ci stanno a Canada, Giappone e Australia, creando un fronte in grado di difendersi dalla minaccia russa e, se necessario, fare militarmente a meno degli Stati Uniti. Non più un semplice patto di consultazione tra capi di Stato e di governo come è stato fin qui, ma una vera e propria entità sovranazionale, dotata di governance e di poteri decisionali, oltre che di risorse. E chi più di Macron avrebbe la necessaria credibilità per farlo? Certo, si tratterebbe di un’operazione complessa, ma se l’orizzonte è la legge di bilancio di fine anno, il tempo per creare le condizioni interne di una nuova candidatura democratica da “front républicain” per l’Eliseo, e quelle internazionali per strutturare i Volenterosi, ci sarebbe.
Scenario difficile e ambizioso? Sì, certo. Ma se Macron non vuole fare la fine che in Italia ha fatto Renzi, altro enfant prodige riformista come lui che è passato dalle stelle alle stalle del consenso popolare, deve trovare il coraggio di provarci. E se lo facesse, noi gliene saremmo molto grati. Per quattro motivi, uno più importante dell’altro. Il primo: perché eviterebbe che il Vecchio Continente cada vittima del patto scellerato Putin-Trump, creando di fatto quell’Europa a due velocità che molti invocano come alternativa alla Ue dell’unanimità paralizzante. Il secondo: perché manterrebbe in vita l’Occidente (Europa più le altre libere democrazie) a dispetto della follia distruttiva americana. Il terzo: perché darebbe un colpo, forse non mortale ma certamente duro, al populismo dilagante, evitando che la democrazia subisca una letale torsione verso la forma di autocrazia elettiva, che è il passo successivo a quello di aver affidato i sistemi politici a identità, partiti e coalizioni, costruite “contro” e non “per”. Infine, il quarto motivo: perché costringerebbe i paesi irrisolti, come l’Italia, a scegliere da che parte stare, il che provocherebbe la caduta del nostro bipolarismo farlocco – accendiamo ceri votivi – facendo esplodere le contraddizioni che attraversano le due coalizioni. Le sembra poco, monsieur Macron? (e.cisnetto@terzarepubblica.it)
L'EDITORIALE
DI TERZA REPUBBLICA
Terza Repubblica è il quotidiano online fondato e diretto da Enrico Cisnetto nato nel 2005 dall'esperienza di Società Aperta con l'obiettivo di creare uno spazio di commento indipendente e fuori dal coro sul contesto politico-economico del paese.