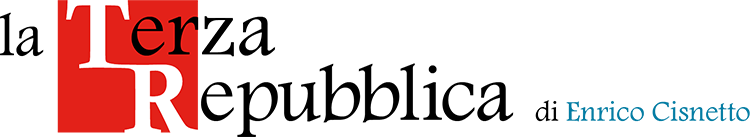Governo Meloni, stabilità senza coraggio
MILLE GIORNI DI STABILITÀ SENZA CORAGGIO (E TROPPO TRUMP). ALLA POLITICA ITALIANA SERVE UNA VERA FORZA DEL CAMBIAMENTO
di Enrico Cisnetto - 25 luglio 2025
Provate a immaginare cosa sarebbe successo in Italia se il governo – non necessariamente l’attuale, qualunque – avesse annunciato, come è accaduto in Francia pochi giorni fa, un aumento della spesa militare di 6,5 miliardi nel corso dei due anni a venire, e nello stesso tempo avesse presentato un piano di riduzione del deficit pubblico di una cinquantina di miliardi basato sull’abolizione di due giorni festivi (per i francesi il lunedì di Pasqua e l’8 maggio), la soppressione di alcune agevolazioni fiscali, il taglio nel pubblico impiego di diverse migliaia di posti di lavoro improduttivi e la mancata sostituzione al momento della pensione di un funzionario ministeriale su tre. Non sarebbe accaduto niente, per il semplice motivo che nessun esecutivo si sarebbe mai sognato di sfidare l’impopolarità con un simile coraggio. Invece a Parigi è successo. Cosa che ha scatenato il finimondo, a destra come a sinistra, come già era avvenuto quando Macron aveva provato ad aumentare l’età pensionabile. E non per il taglio di due punti percentuali rispetto al pil del debito pubblico, che ha superato quello italiano arrivando a 3.345 miliardi, bensì per aver osato sopprimere due giorni di vacanza. Ma il governo non si è spaventato, e tiene il punto. Eppure, nella narrazione comune, specie in Italia, quello di Bayrou è un esecutivo fragile e instabile, e la presidenza Macron è morta e sepolta. Sarà, ma intanto, coraggiosamente, le istituzioni transalpine sferrano un inusitato calcio al basso ventre del populismo, mentre l’Eliseo è il perno, insieme con la Cancelleria Federale di Berlino e Downing Street a Londra, del nucleo (ri)fondante della nuova Europa allargata, quella dei cosiddetti “volenterosi”.
Viceversa, da noi si è commentato il traguardo dei mille giorni del governo Meloni celebrandone la longevità, e di conseguenza la stabilità che assicura al Paese. Di gran lunga messo meglio, si dice, rispetto alla Francia. Ora, è indubbio che quello di Giorgia Meloni sia oggi il quinto governo più longevo della storia della Repubblica, e che in una dozzina di giorni scavalcherà al quarto posto quello di Renzi (1019 giorni) e a metà settembre al terzo posto il Craxi I (1058), ma se dovesse portare a termine la legislatura durerà di più dei due governi Berlusconi, il IV (1283) e il II (1409), che attualmente detengono rispettivamente il secondo e il primo posto in questa classifica di prolungata permanenza a palazzo Chigi. Così come non c’è dubbio che, in generale, la stabilità degli esecutivi e delle maggioranze che li sostengono sia un fattore positivo, apprezzato dai mercati e dal sistema delle imprese, come pure dai comuni cittadini. Ma la stabilità può avere due significati decisamente diversi, se non addirittura opposti. Il primo, davvero positivo, si ha quando la continuità è riempita di contenuti, di scelte, di riforme realizzate, di risultati ottenuti. Nel secondo caso, invece, la stabilità è sinonimo di immobilità all’insegna del tirare a campare. In questo caso essa è fine a sé stessa, e il tempo trascorso non misura più la crescita del Paese ma il suo accontentarsi che sulla scena politica non si producano cataclismi – anche perché, nella circostanza, prevalgono i conflitti interni alle coalizioni, sia di maggioranza che di opposizione, che per istinto di sopravvivenza non arrivano mai a strappi irreparabili – cosa che di solito fa scopa con un diffuso sentimento popolare di rassegnazione e disincanto.
Domanda: è preferibile un governo dalla miccia corta ma capace di incidere o uno a lunga durata ma moscio? Risposta: fermo restando che, “catalanamente”, è meglio averne uno decisionista (nel senso pieno e non recitativo del termine), che duri e che magari si faccia riconfermare dall’elettorato, ma se proprio si deve scegliere tra le due opzioni esposte, io preferisco chi affronta i problemi anche a costo di cadere piuttosto di chi tira la palla in tribuna per guadagnare tempo. Domanda: i mille e rotti giorni meloniani appartengono alla prima o alla seconda delle due fattispecie? Risposta: ad entrambe. No, non è risposta salomonicamente paracula, come potrebbe sembrare. Perché dipende dal metro che si usa per misurare il giudizio. Se si assume quello del minor danno, e quindi si valuta il comportamento della presidente del Consiglio misurando la distanza che separa il suo agire da quanto avrebbe potuto fare e dire sulla base della sua cultura politica e della linea tenuta nel passato quando era all’opposizione – dal sovranismo anti-Ue e anti-euro al populismo più spinto sui temi dell’economia e della società – linea su cui, si badi bene, ha preso i voti che l’hanno portata a palazzo Chigi, allora è evidente che la fattispecie positiva pesa di più di quella negativa. Viceversa, se si usa il criterio della resa rispetto alle esigenze del Paese, allora il piatto della bilancia pende dalla parte della seconda.
Entrando nel merito, a questo governo va prima di tutto riconosciuto di aver tenuto la barra dritta sulla finanza pubblica, non solo evitando ulteriori sforamenti ma realizzando nel 2024 la migliore performance su debito e deficit della storia repubblicana. Non è cosa di poco conto, pur se compensata dall’insistere con la politica dei bonus (in contraddizione con il rigore applicato sul superbonus edilizio). Cui va aggiunto l’impegno a gestire, senza romperlo, il legno nato storto del Pnrr. Ma in economia mancano all’appello diagnosi puntuali sui mali strutturali, idee strategiche, investimenti, riforme. Non pervenuta la competitività, con leggi sulla concorrenza deludenti, e la politica industriale. Si galleggia sulla congiuntura, la quale ci dice che da tre anni la produzione industriale declina e che il pil ha esaurito un minimo di spinta ed è indirizzato alla crescita zero (al netto dell’effetto dei dazi americani, che una volta in vigore nella probabile formula del 15%, considerata erroneamente accettabile in sede europea, non potranno che generare recessione). Le riforme istituzionali, per fortuna, sono state abbandonate strada facendo, con la sola eccezione della separazione delle carriere, che è cosa che ci prendiamo volentieri anche se mal formulata, ma che certo non è l’organica riforma della giustizia attesa da decenni e di cui il Paese ha drammaticamente bisogno. Il resto, sul piano interno, sono minuzie o vecchi copioni del teatrino politico.
Certo, le questioni internazionali hanno preso il sopravvento. Inevitabilmente, visto gli sconquassi cui stiamo assistendo. Solo che l’epocalità dei cambiamenti richiede un salto quantico nella capacità di lettura dei fenomeni e nelle conseguenti assunzioni di responsabilità. Cosa che presuppone leadership strutturate e coraggiose – in una parola, statisti – e sistemi politico-istituzionali consolidati. Meloni e l’Italia in tutto questo? Anche qui dipende dal metro di misura. Ci si può accontentare, come fanno taluni osservatori e analisti di bocca buona, della fermezza dimostrata sull’Ucraina e nel pensare che poteva andare peggio. E in questo caso vale la constatazione di aver visto Meloni passare da una posizione di radicale opposizione alla Commissione Ue ad una di appoggio esterno corroborata da un rapporto amicale con Ursula von der Leyen (che di questa apertura a destra è stata accusata dalla sinistra della sua stessa maggioranza, senza per questo essere sfiduciata). Oppure, al contrario, si assume come principale fattore di valutazione il rapporto con Trump, e allora è inevitabile guardare con preoccupazione l’attardarsi della presidente del Consiglio a coltivare la fallace illusione di poter fare da ponte tra il presidente americano e l’Europa. Cui si accompagna il rammarico per i futili distinguo verso i “volenterosi” e le fragili argomentazioni usate sul riarmo. Posizioni che ora Meloni ha attenuato, ma con un rinculo ancora insufficiente.
Insomma, da un lato, incertezze, errori di valutazione, strabismi, supponenze, eccessi di propaganda e durezze mal riposte, con relativo coté di polemiche inutili. Dall’altro il binomio “impegno e indubbie capacità”, che una parte dell’opinione pubblica le riconosce, anche da parte di chi non l’ha votata, aiutata in questo dalla miserevole povertà delle alternative. E qui vengo ad un’altra considerazione: sarebbe sbagliato, prima ancora che ingeneroso, attribuire solo a Meloni, al suo governo – che pure merita un voto decisamente peggiore rispetto a quello della presidente del Consiglio – e alla coalizione di centro-destra, disomogenea su quasi tutto ma soprattutto sul tema dirimente della politica internazionale, la responsabilità del disfunzionamento della politica italiana, sempre più evidente e grave. Sappiamo bene che, specularmente, i problemi e i limiti del centro-destra sono anche del centro-sinistra, cosa che l’affannosa ricerca del “campo largo”, con il Pd di Elly Schlein consegnato mani e piedi al populismo dei Cinquestelle e al radicalismo di Landini, rende quotidianamente evidente.
La verità è quella che in questa sede vado denunciando da (troppo) tempo. Ad essere difettoso – e ora, nel contesto mondiale, drammaticamente e pericolosamente inadeguato – è il sistema politico-istituzionale nel suo insieme. Il bipolarismo italico non ha mai funzionato, fin dal suo esordio nel 1994. Tanto meno la sua versione bipopulista, nata con l’assurgere sulla scena politica del movimento qualunquista di Grillo e consolidata con l’inquietante affermarsi dell’avvocato Conte, prima come presidente del Consiglio e poi come “padrone” di quel che resta dei 5stelle. La vittoria nel 2022 del destra-centro non ha risolto il problema, anzi ha certificato che la politica italiana è costretta dentro uno schema di coalizioni elettorali disomogenee e incoerenti, buone solo per l’insopportabile teatrino dei talk show. È dunque continuato lo svilimento del ruolo dei partiti, anche con l’accentuarsi del fenomeno della personalizzazione della politica e del leaderismo, l’impoverimento delle classi dirigenti, l’immiserimento del Parlamento. Le istituzioni si sono depauperate, perdendo credibilità, e la loro architettura complessiva, a cominciare da quella relativa al decentramento amministrativo, appare tanto elefantiaca e barocca quanto inefficiente.
È dunque il sistema politico e quello istituzionale che vanno ridefiniti, e sono straconvinto che se domani un soggetto politico avesse la lungimiranza e la forza di proporsi al Paese con una diagnosi spietata della malattia e con una coraggiosa terapia conseguente, farebbe strike conquistando un consenso maggioritario perché andrebbe a recuperare quella sempre più grande parte degli astensionisti che sono tali per costrizione e non per qualunquismo, e non aspettano altro che qualcuno li desti dal torpore cui sfiducia e disillusione li hanno precipitati. Non sto parlando, dunque, di un banale Terzo Polo, caratterizzato solo dall’essere distinto rispetto alle due attuali coalizioni, e che per definizione ha – al di là del frazionismo già sperimentato – le stigmate della piccola enclave minoritaria. No, sto parlando di qualcosa di molto più imponente. Perché la necessità del cambiamento radicale di cui il Paese ha bisogno per risollevarsi è talmente grande, che le piccole operazioni di minoranza, per quanto animate da buone intenzioni e realizzate da gente rispettabile, sono già in partenza destinate al fallimento. Ovviamente, tanto più è alta l’asticella dell’ambizione, tanto maggiore è la difficoltà. E infatti, ciò di cui parlo richiede risorse, supporto culturale e mediatico, una borghesia del fare, consapevole delle sfide che abbiamo davanti e del proprio ruolo sociale, disposta a mettersi in gioco. Significa partire non da un leader, vero o presunto, che coopta gregari, ma da una élite che aggrega forze intorno ad un lavoro di elaborazione, e nel farlo fa maturare leadership plurali. Insomma, roba tosta, difficile, complicata, lo so. Impossibile? Può essere. Ma è l’unica operazione politica che può avere la forza di interrompere il ciclo del declino italiano che dura da oltre tre decenni. E che, dunque, valga la pena di essere tentata.
Altrimenti? Altrimenti si sta nel gioco che ci ha portato fin qui. Si sceglie se provare a migliorare il centro-destra, magari affidandosi all’idea che portare un cognome sperimentato sia sufficiente a generare processi innovativi e ad alimentare speranze. Oppure, volgendosi sull’altro fronte, si predispone lo stomaco a digerire un’ammucchiata di tutti coloro che considerano questa destra il male peggiore e non vogliono che rivinca, non fosse altro perché nella prossima legislatura si eleggerà il nuovo presidente della Repubblica. Oppure, infine, ci si rifiuta di fare entrambi i sacrifici, e si tacita la propria coscienza con una onorevole quanto sterile opera di testimonianza. Tutte opzioni legittime, sia chiaro, anche nobili se animate da buone intenzioni. Ma, temo, frustranti. Il mondo sta cambiando vorticosamente e ad una velocità senza precedenti, tanto da mettere in forse i capisaldi del nostro modo di vivere nell’ambito di storiche alleanze, cui ci eravamo volentieri abituati. Se non ci si rende conto di quanto sta accadendo, dei pericoli che stiamo correndo, e non ci si attrezza di conseguenza, trovarci in una dimensione finora inimmaginabile non sarà un rischio, ma una certezza. Per questo l’Italia e l’Europa sono chiamate a scelte tali che cancellare due storiche festività sarebbe il minimo, altro che un sacrilegio. Scelte che richiedono un impegno politico fuori dall’ordinario. Pensiamoci, mentre stacchiamo la spina per il meritato riposo estivo, nella consapevolezza che i problemi non vanno in ferie e che alla ripresa ci vorrà un supplemento straordinario di consapevolezza e di coraggio.
Nel frattempo, cari lettori, buone e serene vacanze. Ci ritroviamo a settembre. (e.cisnetto@terzarepubblica.it)
L'EDITORIALE
DI TERZA REPUBBLICA
Terza Repubblica è il quotidiano online fondato e diretto da Enrico Cisnetto nato nel 2005 dall'esperienza di Società Aperta con l'obiettivo di creare uno spazio di commento indipendente e fuori dal coro sul contesto politico-economico del paese.