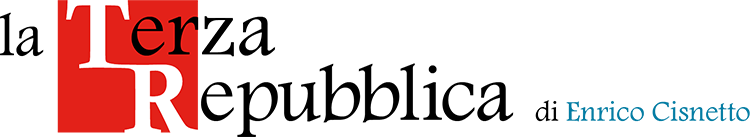Il regalo di Trumop ai Brics
TRUMP REGALA AI BRICS IL VESSILLO DEL LIBERO COMMERCIO E LA DIFESA DELLA GLOBALIZZAZIONE. L’EUROPA DEVE ANDARE OLTRE LA “NON SFIDUCIA” A VON DER LEYEN
di Enrico Cisnetto - 11 luglio 2025
Non ho mai nutrito alcuna simpatia per i Brics. Lo so che rappresentano la metà della popolazione mondiale e quasi il 30% del pil globale, e che contribuiscono a creare più del 50% della crescita economica planetaria. Ma non mi è mai piaciuta l’egemonia che su “il sud del mondo” hanno sempre esercitato, e tuttora esercitano, Russia e Cina. Tuttavia, di fronte alla sortita di Donald Trump (una delle tante) secondo cui tutti coloro che si allineano con i Brics e le loro politiche, giudicate antiamericane, saranno puniti con un dazio aggiuntivo del 10% – così, tanto per regolare i rapporti politici con le armi della guerra commerciale – mio malgrado fatico a non avere un moto di solidarietà. Tanto più che la minaccia dell’inquilino della Casa Bianca è stata scatenata da una – sacrosanta – frase di condanna dei “dazi unilaterali e altre barriere protezioniste”, senza neppure citare gli Usa, usata in un comunicato dei Brics al termine del loro recente summit di Rio de Janeiro. Inoltre, non si può non riconoscere l’indubbio ruolo propulsivo per l’economia globale svolto da questi paesi, che continuare a chiamare “emergenti” è ormai fuori luogo – si pensi, per esempio, alla crescita che sta avendo l’India – tanto che oggi, nel pieno della stagione di “anarchia geopolitica” inaugurata con il secondo mandato presidenziale di Trump che rischia di dissolvere l’Occidente e mortificare l’economia di mercato, i Brics (Russia a parte) appaiono come i principali sostenitori della globalizzazione, o di quel che ne resta. E non è un merito da poco, se è vero come è vero che – al di là di errori e forzature, come il dilagare del capitalismo finanziario fine a se stesso, che comunque sono sempre fisiologici in qualunque fenomeno epocale – la globalizzazione ha portato la diffusione del benessere e della libertà economica (purtroppo non della democrazia) in ampie parti del globo che fino all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso ne erano prive.
Ed il merito è tanto più grande considerando che a mettere in crisi l’integrazione economica mondiale è il paese fin qui simbolo e guida di questo processo. Con la guerra dei dazi e il protezionismo che la sottende, infatti, gli Stati Uniti di Trump si sono assunti la responsabilità storica di mettere i bastoni tra le ruote della globalizzazione, proprio in una fase in cui prima la grande crisi finanziaria del 2008 e seguenti, poi il Covid e le guerre, quella russa e quella mediorientale, l’avevano fiaccata, ma non fermata. Certo, l’accorciamento, in chiave di macro-aree più omogenee (la cosiddetta “regionalizzazione”) delle catene del valore (forniture e commerci) era già iniziata prima del ritorno di The Donald alla Casa Bianca, ma pareva un sano aggiustamento di quel fenomeno, non una sua messa in discussione. Ora, invece, l’America First si afferma come una contro-teorizzazione ideologica, prima ancora che un sabotaggio pratico per il tramite delle tariffe doganali. E un conto è correggerne gli errori, ridefinirne le traiettorie, un altro è uccidere la globalizzazione. Un obiettivo – insano – che finora si erano dati i movimenti “no global”, i cantori della “decrescita felice”, non gli alfieri del turbo-capitalismo.
Succederà? Non lo so, la volubilità quotidiana del trumpismo non consente di fare previsioni. L’unica cosa certa è che se dovesse accadere, per l’umanità sarebbe un vero disastro, sia per i miliardi di persone che ancora aspirano al salto di qualità – si pensi all’Africa – sia per i paesi ricchi, che perderebbero un volano di crescita e dunque di consolidamento del livello del loro benessere (altra questione, che attiene alle politiche nazionali, o nel nostro caso europee, è la redistribuzione più equa della ricchezza all’interno di questi paesi, che hanno più o meno tutti una classe media in affanno e dunque carica di rabbia). Ma ora sappiamo che nonostante tutti i colpi ricevuti, la globalizzazione gode di una capacità di resilienza davvero notevole. Il che è un bene, anche se fa rabbia vedere il vecchio Occidente lasciare alla Cina e alla ventina di nazioni associate ai Brics – la platea definita “Brics+”, che ha visto l’adesione di paesi come Emirati, Egitto, Etiopia, Indonesia e, udite udite, Iran – interpretare il ruolo di alfieri dell’integrazione economica mondiale, difendere le regole del Wto e tutelare il commercio internazionale sulla base del multilateralismo degli scambi. Anche perché in quel contesto articolato e con interessi non necessariamente convergenti, Putin spinge per un altro schema di gioco, assai pericoloso: nel sostenere che la globalizzazione così come l’abbiamo conosciuta e fin qui vissuta “è obsoleta”, l’autocrate del Cremlino vorrebbe che G7 e Fondo Monetario venissero surrogati, sia sul piano politico e strategico sia su quello economico e finanziario, dai Brics+ a trazione (ideologica) russa. Il tutto al fine di cancellare dallo scenario geopolitico il vecchio Occidente.
Un disegno, quello putiniano, cui Trump è funzionale – consciamente o inconsciamente, non fa molta differenza – e non saranno certo le parole spese ultimamente contro Zar Vlad (“dice stronzate”) e “a favore” (si fa per dire) di Zelensky sulla fornitura di missili Patriot (“non glieli do più”, “glieli darei ma è costoso”, “forse glieli do”, il tutto nel giro di una settimana) che attenuano la sostanziale convergenza dei due. Come dimostra la sceneggiata dei dazi, finora più recitata che praticata, le cui conseguenze strategiche sono il picconamento dell’Occidente e la messa in crisi della globalizzazione, cioè due facce della stessa medaglia che vanno a tutto favore dell’ordito putiniano che punta alla completa ridefinizione degli equilibri planetari consolidatisi nei decenni post bellici, dalla Guerra Fredda in poi, e che non riguardano soltanto l’Europa e l’Asia ma anche il Medio Oriente, come dimostra la “finta guerra” di Trump all’Iran, principale alleato della Russia.
In questo contesto, l’Europa appare più spettatrice passiva che attore dotato di un proprio disegno unitario, preoccupata ma impotente. Ne ha dato dimostrazione con il ridicolo, ma proprio per questo significativo, momento introspettivo vissuto con la mozione di sfiducia, respinta come da previsioni ma nonostante questo tribolata, nei confronti della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Ci sono due modi opposti, ma non necessariamente alternativi, per valutare la “non sfiducia” del parlamento europeo sulla mozione di censura presentata da un parlamentare romeno di estrema destra e, guarda caso, filo-putiniano. Il primo è compiacersene, il secondo è preoccuparsene. Esaminiamoli entrambi, ma soprattutto vediamo perché vanno presi in considerazione entrambi, insieme, senza cadere in alcuna contraddizione.
Militano a favore del compiacimento per il no a quella mozione, diversi argomenti. Il primo è la natura speciosa dell’iniziativa – che riguardava una vicenda di anni fa, relativa alla campagna Ue di approvvigionamento e distribuzione dei vaccini durante l’emergenza Covid – e il profilo squalificato e squalificante del suo presentatore, membro del gruppo Ecr da cui gli europarlamentari italiani di Meloni hanno, per fortuna, preso le distanze. Il secondo attiene ad una valutazione politica generale: tutto ha bisogno oggi l’Unione Europea, nel pieno di una fase di anarchia geopolitica planetaria, meno che di una crisi della Commissione. Il terzo è di realpolitik: se dovesse andare in frantumi l’asse popolari-socialisti, più liberali e verdi, su cui si regge il secondo mandato di von der Leyen, non ci sarebbe alcun’altra coalizione possibile, né sembra realistico pensare alla stessa maggioranza ma con un'altra personalità alla presidenza della Commissione. Tra l’altro, rispetto al precedente mandato, Ursula ha accumulato nelle sue mani maggiore potere e dunque oggi, nonostante i suoi limiti e difetti, appare insostituibile. Infine, ci sono due ragioni politiche per cui è stato un bene che a Strasburgo si sia votato contro la sfiducia. La prima: il trasformismo di cui è stata accusata von der Leyen in realtà ha consentito di spaccare il fronte sovranista, come dimostrano i mal di pancia in casa Ecr e la frattura tutta italiana tra la Lega (che ha votato sì alla mozione) da una parte e Forza Italia (che ha votato contro) e Fratelli d’Italia (che non ha partecipato al voto) dall’altra. Non è un cattivo risultato, al di là che certifica che l’Italia è guidata da una maggioranza disomogenea (come lo è l’opposizione, peraltro, visto che gli europarlamentari di Conte si sono uniti a quelli di Salvini, mentre per fortuna il Pd ha evitato di fare sciocchezze). La seconda ragione: i motivi di insoddisfazione dei gruppi della “maggioranza Ursula” nei confronti di von der Leyen non sono quelli giusti. La presidente viene accusata di flirtare con le destre, e per colpa di questa apertura di essere intenzionata a mettere in discussione alcuni punti del programma, a cominciare dalla “agenda verde” e i nuovi target climatici al 2040. Ora, da un lato ripensare alcune politiche, fin qui intrise di ideologismo, non è affatto un peccato, anzi, è un bene e un’opportunità, specie se parliamo di mitigazione e non di rovesciamento dei paradigmi. Inoltre, nello scenario internazionale, le schermaglie che vedono contrapposti socialisti, liberali e verdi da un lato e popolari dall’altro, francamente appaiono lunari: l’Europa, schiacciata nella morsa trumpiana della guerra dei dazi e della revisione (per non dire abbandono) della solidarietà euro-atlantica, ha ben altro tipo di problemi.
E qui veniamo all’altra faccia della medaglia. La paralisi di cui è affetta l’Europa, che sconta ritardi pluridecennali (dall’avvento dell’euro in poi) e tentennamenti perpetui nel portare a compimento il processo di integrazione politico-istituzionale, non è certo imputabile alla sola von der Leyen o a questa Commissione, ma è un fatto che l’attuale architettura comunitaria non è più adeguata e sufficiente ad affrontare le sfide epocali del presente. Lo dimostrano le iniziative assunte direttamente dalle cancellerie dei paesi maggiori, le continue consultazioni (a geometria variabile) dei principali leader continentali, per non dire della creazione della “coalizione dei volenterosi” che ha coinvolto anche realtà occidentali non europee. Tutte cose opportune e meritevoli, sia chiaro, non fosse altro perché surrogano un potere comunitario che non c’è, ma che indicano senza tema di smentita il livello di consunzione delle istituzioni di Bruxelles e Strasburgo. Una questione, la riorganizzazione su altre basi dell’Europa, che va affrontata subito, presa di petto, se non si vuole che la ridefinizione degli equilibri mondiali in corso non ci veda sciaguratamente perdenti. Ma che di certo non passa per la messa in discussione di Ursula von der Leyen.
La Confindustria italiana e quella francese (Medef) hanno lanciato un comune grido d’allarme: “l’Europa sta vacillando. Le sue fabbriche chiudono. Le sue bollette energetiche aumentano. La sua voce si affievolisce. Il suo peso geopolitico si riduce. In un mondo segnato dagli shock geopolitici, l'indecisione rappresenta la minaccia più grave. L'Europa deve scegliere: competere o declinare, essere un mercato o una macro regione produttiva”. Ecco, siamo chiari: il riscontro a questo appello, le risposte alle grandi questioni europee rese esplosive dalla presidenza Trump ma latenti da tempo, non passano da Bruxelles, ma da Berlino, Parigi, Varsavia e, si spera, Roma e Madrid. Possibilmente d’intesa con Londra, Ottawa e Camberra. È in queste cancellerie che vanno trovate risposte ai problemi di nuovi equilibri dentro la Nato, e di conseguenza nell’organizzazione del sostegno all’Ucraina a prescindere dall’impegno americano (appeso alla insopportabile volubilità quotidiana di Trump), così come vanno individuate le strategie sia per affrontare la sfibrante guerra commerciale trumpiana sia per immaginare le nuove architetture istituzionali comunitarie del futuro.
Insomma, bene che Ursula von der Leyen sia rimasta al suo posto, ma per vincere la partita con la storia tocca che Macron, Merz, Tusk, Starmer, Meloni e Sanchez si convincano di essere degli statisti, non dei politici buoni sì e no per una stagione. (e.cisnetto@terzarepubblica.it)
ps. finisco di scrivere questa newsletter, che invio con un giorno di anticipo, senza che la benedetta lettera di Trump all’Unione Europea che dovrebbe chiarire (si fa per dire) le intenzioni americane sui dazi sia partita, o comunque resa nota. Ammesso e non concesso che metta la parola fine a questa folle questione, che finora ha fatto danni solo per l’incertezza che ha generato, toccherà farne oggetto di riflessione la prossima settimana. Intanto buon weekend, se potete.
L'EDITORIALE
DI TERZA REPUBBLICA
Terza Repubblica è il quotidiano online fondato e diretto da Enrico Cisnetto nato nel 2005 dall'esperienza di Società Aperta con l'obiettivo di creare uno spazio di commento indipendente e fuori dal coro sul contesto politico-economico del paese.