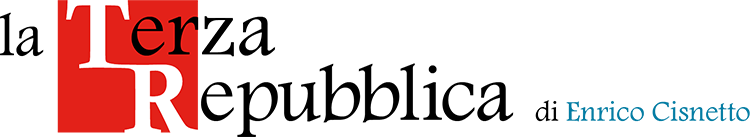Trump inaffidabile e Meloni isolata
TRUMP CAMBIA REPENTINAMENTE IDEA SU DAZI E POLITICA ESTERA, PER L’ITALIA NON CAPIRLO PORTA AD UN PERICOLOSO ISOLAMENTO
di Enrico Cisnetto - 17 maggio 2025
È più pericoloso il Trump che aumenta i dazi degli Stati Uniti come mai da oltre un secolo scatenando una guerra commerciale planetaria, o quello che solo un mese dopo fa marcia indietro, persino con la Cina a cui aveva appioppato tariffe del 135%? Fa più paura il Trump che blandisce Putin fino a sembrarne subordinato e infierisce su Zelensky mortificandolo, o quello che come se niente fosse assume la postura opposta fino a prendersi un sonoro ceffone dall’autocrate russo che rifiuta il suo invito a recarsi al vertice di Istanbul per aprire la prima trattativa di pace dopo oltre tre anni di guerra? La risposta sembra ovvia: in entrambi i casi le seconde opzioni, quelle che ci restituiscono un Trump più mansueto e ragionevole, sono le preferibili. E invece no. Le due opzioni si equivalgono, in negativo. Per almeno tre ottime ragioni. La prima: i repentini cambi di atteggiamento mostrano l’inaffidabilità del presidente americano, cosa che rende poco credibile ogni sua presa di posizione e induce – o dovrebbe indurre – gli interlocutori alla massima prudenza. La seconda: questa modalità di comportamento – frutto di un mix di impreparazione, opportunismo, egocentrismo e affarismo – produce un livello insopportabile di instabilità, che in politica e nelle relazioni internazionali è più temibile delle posizioni avverse, ma chiare e lineari. Terza e più importante ragione: il Trump che attacca induce anche i più accondiscendenti a reagire, o quantomeno a stare in allerta, mentre quello che rincula e sembra più ragionevole spinge ad abbassare la guardia o, peggio, a trovare la scusa per autoassolversi delle iniziali simpatie nei suoi confronti, della serie “avete visto, malfidati, non è così pessimo come lo avete voluto descrivere”.
Dico questo perché colgo nei media più ancora che nella politica italiana la tendenza al compiacimento per una Casa Bianca friendly, che consente a molti – dopo aver temuto di doversene vergognare – di giustificare il proprio trumpismo, militante o malcelato che sia. Parlo, per esempio, di chi fa finta di non vedere le forzature autoritarie impresse da Trump alla politica americana, a cominciare dalla torsione nei confronti dei contropoteri e delle autorità indipendenti (vedi i volgari attacchi al presidente della Federal Reserve, Powell) fino al punto di far saltare il sistema costituzionale, quasi che fossero questioni interne di un paese amico su cui non è fair mettere becco. O di chi di fronte alla violenta e ingiustificata aggressione commerciale a mezzo mondo, si è mostrato comprensivo e ha subito teso a dire che bisognava trattare, e ora si attribuisce il merito del dietrofront, facendo finta di non capire che è stata la reazione avversa dei mercati, Wall Street in testa, e della stessa opinione pubblica americana, e non certo la loro acquiescenza, a indurre The Donald a cambiare registro. O, ancora, parlo di chi non fa un plissé di fronte alla commistione di interessi pubblici e privati spudoratamente praticata dal tycoon – al confronto Berlusconi era un’educanda – tra criptovalute messe sul mercato a scapito del dollaro e l’aereo da 400 milioni che si è fatto regalare dai qatarini. Finendo così per considerare normale ciò che non lo è, e non solo per una mera questione di eleganza. Ma, soprattutto, mi riferisco a coloro che non hanno ritenuto di doversi indignare di fronte agli insulti che il presidente americano e i suoi, Vance in testa, hanno rivolto all’Europa e agli europei – da ultimo asserendo che siamo peggio dei cinesi – forse perché non si sentono tali, ma solo italiani.
Si tratta di atteggiamenti pericolosi, oltre che sbagliati. Perché inducono a commettere l’errore di sottovalutare i rischi che stiamo correndo. E che discendono dal cambiamento radicale del contesto geopolitico – il secolo americano – nel quale, nel corso dei decenni, ci siamo tutti abituati a vivere, compresi quelli che lo hanno contestato o addirittura demonizzato (per capirci, quelli che scrivevano amerikani con la k). Chi mi segue ricorderà che ne ho parlato a novembre al momento della vittoria elettorale di Trump, e a maggior ragione l’ho ribadito a gennaio fin dai primi giorni del suo (re)insediamento alla Casa Bianca: l’alleanza atlantica è andata in pezzi, il tempo dell’Occidente a guida americana è finito. Con la morte nel cuore, coltivando la speranza di poter un giorno incollare i cocci, ma va preso atto che le cose stanno così. Per questo, un conto è evitare che questa consapevolezza si tramuti in atti di rottura da parte dell’Europa e dei paesi che la compongono, sbattendo la porta, un altro è far finta di niente porgendo l’altra guancia o, peggio, ignorare e mostrarsi proni.
Purtroppo, questo errore di valutazione l’ha commesso, a più riprese, il governo italiano. In particolare, in occasione di due viaggi di Meloni, uno quello effettuato a Washington – privo di effetti concreti e utili e nello stesso tempo intriso di subordinazione, mentale e psicologica prima ancora che pratica – e l’altro quello mancato a Kiev, raggiunta in treno da Macron, Starmer, Merz e Tusk tre anni dopo l’analoga visita dello stesso presidente francese con Scholz e Draghi (si veda la War Room di martedì 13 maggio, qui il link). Per la presidente del Consiglio è grave non aver capito – specie alla luce della forte impronta simbolica lasciata e rimasta nel tempo dalla attiva presenza del suo predecessore su quel treno per la capitale ucraina all’inizio della guerra scatenata da Putin – che partecipare in videoconferenza non sarebbe stata la stessa cosa, sia nel percepito dell’opinione pubblica, sia nel concreto delle relazioni diplomatiche, che vanno ben oltre una photo opportunity. In realtà, dietro quella scelta c’è appunto una lettura sbagliata delle dinamiche geopolitiche in atto. Che è la somma di tre diversi errori di valutazione. Il primo riguarda il suo rapporto con Trump, quella illusoria “very special relationship”, in nome della quale mantiene un equilibrio ambiguo con Bruxelles e i partner europei. Doppiezza che, nella sua testa, sarebbe mascherata dal feeling personale – fin qui ricambiato, ma destinato a dissolversi ben presto – con la presidente della Commissione europea von der Leyen. Questo errore ne contiene due: credere che dal presidente americano ci si possa cavare qualcosa per il solo fatto di non contraddirlo; pensare che l’Europa possa tollerare il suo tenere il piede in due scarpe.
Il secondo errore di valutazione attiene alla mancata comprensione di come in questa fase, in Europa contino più Parigi e Berlino di Bruxelles. La rivitalizzazione dell’asse franco-tedesco – simbolicamente suggellata dalla visita all’Eliseo di Merz come primo atto del suo mandato di cancelliere e consolidata dal fatto che Macron e Merz hanno avuto un comune trascorso professionale nel mondo finanziario che ha cementato il loro rapporto personale al di là della politica – non può non porre a Roma, a qualunque governo fosse in mano, il tema di scegliere se farne parte o meno. Sapendo che l’asse è destinato, con Varsavia, a diventare, o forse è già, un triangolo, e che in questa fase la Polonia ha un peso enorme, detenendo la forza militare più grande d’Europa e avendo un obiettivo di crescita esponenziale delle sue forze armate che la piazzerà al terzo posto nella Nato dopo Stati Uniti e Turchia. Finora Meloni non è entrata nell’agenda del nuovo cancelliere tedesco – salvo l’incontro che ci sarà, più per buona educazione che altro, a margine dell'insediamento di Papa Leone XIV – e vive con frustrazione il rapporto con il presidente francese, che odia cordialmente. Ma così le restano – ma soprattutto, restano all’Italia – Orban e Fico (per fortuna è stata cancellata un’inopportuna visita a palazzo Chigi), e non è proprio la stessa cosa. Sia nello specifico della vicenda russo-ucraina, visto che i due stanno palesemente con Mosca, sia più in generale per tutti i dossier e gli equilibri continentali che si vanno formando.
E qui arriva il terzo errore di Meloni, riguardante la “coalizione dei volenterosi”. Già, perché in realtà la partecipazione del premier inglese Starmer al gruppo informale che in ambito occidentale si è costituito una volta preso atto delle posizioni enti-europee dell’amministrazione americana, ha reso ancor più debole Bruxelles, spostando il baricentro delle decisioni al quadrilatero Londra-Parigi-Berlino-Varsavia. Esattamente quello che ieri a Tirana ha messo Macron, Merz, Starmer e Tusk al cospetto di Zelensky, reduce dal vertice declassato (per responsabilità di Putin) che si è svolto in Turchia, quartetto che insieme al presidente ucraino ha poi avuto un colloquio telefonico con Trump per manifestare il disappunto per la pervicace indisponibilità russa ad un cessate il fuoco completo e incondizionato come premessa di una vera trattiva di pace e chiedere che Ue e Usa siano unite nel sanzionare Mosca (si veda la War Room di giovedì 15 maggio, qui il link). Perché Meloni non c’era? Eppure, l’incontro è avvenuto nella capitale albanese subito dopo la sessione plenaria del summit della Comunità Politica Europea, cui la nostra presidente era presente.
L’altro giorno in Parlamento – stendiamo un pietoso velo sull’indecorosa sceneggiata cui un po’ tutte le parti hanno dato vita, a conferma del drammatico scadimento della vita politica italiana e dei suoi attori – è riecheggiata la solita motivazione della distanza italiana dai “willing”, e cioè la contrarietà all’intenzione dei “volenterosi” di coinvolgere direttamente truppe militari per proteggere i confini dell’Ucraina. Ora, a parte che nessuno ha mai posto la questione dell’eventuale invio di truppe – peraltro solo dopo la fine della guerra, che è di là da venire – come conditio sine qua non per salire sulla “carrozza dei volenterosi”, il pretesto, perché di questo si tratta, è assai debole. Nulla vieta di partecipare e poi, se e quando sarà il momento, di prendere strade diverse. La verità è che mentre non c’è alcun pregiudizio sull’Italia, in Europa e in Occidente, altrimenti ci sarebbe stato anche ai tempi di Draghi, al di là della sua personale caratura internazionale, ce n’è uno italiano grande come una casa verso l’Europa e le altre leadership continentali e occidentali. Dal quale discende, inevitabilmente, una diffidenza verso il governo Meloni (accentuata dalle posizioni di Salvini) e la sua politica estera. Flirtare con Trump e tenere un equilibrio ambiguo coi partner europei si è rivelata una strategia effimera e doppiamente controproducente, perché la chimera dei rapporti privilegiati con la Casa Bianca ha, di fatto, relegato Roma a comparsa sul fronte europeo e nello stesso tempo non ha consentito di portare a casa niente – come era facilmente prevedibile, non fosse per la strabordante egolatria del presidente americano – da Washington. E non può essere una giustificazione, agli occhi né degli interlocutori internazionali né di tutti gli italiani, la necessità di Meloni di dover badare alla tenuta della maggioranza di governo evitando rotture. Tutte le coalizioni di governo abbisognano di un certo grado di mediazione e compromesso, e in Italia in particolare, ma c’è un limite oltre il quale si entra in uno stato di immobilismo che diventa tirare a campare.
Ecco, dunque, cosa c’è alla base dell’(auto)isolamento italiano: una scelta politica velleitaria e ambigua di cui ora si è chiamati a pagare le conseguenze. Peccato che il fio non lo paghino solo la presidente del Consiglio e le forze politiche che la sostengono, ma l’intero Paese. Messo fuorigioco in un momento in cui, addirittura, è in discussione la tenuta della solidarietà euro-atlantica, cioè l’architrave su cui abbiamo ricostruito l’Italia dalle macerie della Seconda guerra mondiale, assicurandogli democrazia e benessere. Né può consolare il fatto che se al governo ci fosse il “campo largo” le cose non starebbero andando meglio. Vuoi per la posizione trumputinista di Conte, vuoi per la profonda spaccatura interna al Pd. Già, non si capisce con quale faccia Schlein rimproveri a Meloni l’assenza a Kiev: non è forse la medesima posizione espressa dalla segretaria alla direzione del suo partito, quando dichiarò che il Pd non stava né con Trump e il suo “finto pacifismo” né con l’Europa che vuole “continuare la guerra”? La verità è che è la postura dell’intero sistema politico, con qualche lodevole eccezione, ad essere inadeguata rispetto alle questioni epocali cui siamo di fronte. Mala tempora currunt… (e.cisnetto@terzarepubblica.it)
L'EDITORIALE
DI TERZA REPUBBLICA
Terza Repubblica è il quotidiano online fondato e diretto da Enrico Cisnetto nato nel 2005 dall'esperienza di Società Aperta con l'obiettivo di creare uno spazio di commento indipendente e fuori dal coro sul contesto politico-economico del paese.