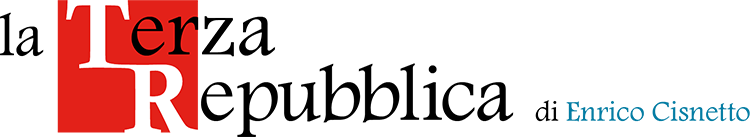4 ambizioni per salvare economia globale e Occidente
STATI UNITI D’EUROPA, COALIZIONE DEI VOLENTEROSI, RAPPORTO CON LA CINA, UNA NUOVA BRETTON WOODS
di Enrico Cisnetto - 17 aprile 2025
È una Pasqua di passione, quella di Giorgia Meloni. Scrivo senza conoscere l’esito del suo incontro con Donald Trump, ma mi azzardo a pronosticare che nel migliore dei casi sarà un viaggio inutile, mentre nel peggiore si rivelerà pieno di incognite e di rischi. Va detto che la presidente del Consiglio alla vigilia ha assunto la postura giusta, tra fitti colloqui con Ursula von der Leyen, pubbliche dichiarazioni di prudenza (“siamo in un momento difficile”) e private richieste ai soci di governo di tenere la lingua a freno. Peccato, però, che la sua sia una consapevolezza a intermittenza, che il vertice che ha così tanto agognato contenga un’insanabile contraddizione – è bilaterale ma non dovrebbe esserlo, dovrebbe essere europeo ma non lo è – e, infine, che l’interlocutore abbia già messo le mani avanti sui dazi e soprattutto che sia del tutto inaffidabile. Vedremo quale sorpresa Meloni troverà nell’uovo pasquale americano, e cosa lei metterà in quello che donerà agli italiani. Perché una cosa deve essere chiara: siccome “la posta in palio è troppo alta”, come lei stessa ha ammesso, in gioco non c’è solo la sua leadership e la sua carriera politica, c’è soprattutto il presente e il futuro dell’Italia in un passaggio della storia che non consente errori. Due in particolare.
Il primo di questi errori da evitare è sbagliare l’analisi. Mentre non solo il governo, ma l’intero sistema politico, gran parte dei media, del mondo intellettuale e della business community mostrano di aver capito poco di quel che sta accadendo. Non siamo davanti ad un terremoto, che farà pure disastri ma consente di ricostruire e rimettere le cose al loro posto. No, siamo di fronte, come ha detto il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè nella War Room di martedì 15 aprile dedicata al “duello Usa-Cina” (con anche Alessandro Aresu e Matteo Dian, qui il link), ad uno spostamento della faglia sotterranea degli equilibri planetari dovuto ad una corrosione profonda sia del ruolo geopolitico degli Stati Uniti nell’Occidente e nel mondo, sia della sua primazia economico-finanziaria, tale per cui ogni altro attore si sente legittimato ad occupare nuovi spazi, a stabilire nuove alleanze, a giocare nuove partite. Si è chiuso il ciclo, durato otto decenni, dell’ordine multipolare in cui l’America è stata avamposto della democrazia liberale, garante della sicurezza e della stabilità, sentinella delle regole, detentrice dell’ordine monetario con il dollaro quale valuta di riserva globale. E si badi bene, a chiuderlo, questo ciclo, non sono stati i suoi nemici – l’altro ieri il comunismo organizzato, ieri l’islamismo integralista, oggi la Cina – né il pur diffuso sentimento anti americano che dal 1968 permea tanti movimenti, a cominciare da quelli pacifisti, e riempie tante piazze manifestanti. No, ci hanno pensato loro stessi ad abdicare al ruolo di custodi dell’ordine internazionale, nel pieno di una pulsione autolesionista che ha trovato in Trump il leader che ha saputo dargli corpo. Ma che viene da lontano: dagli errori dei vecchi repubblicani, come quello di Bush jr in Iraq, e da quelli dei democratici delle ultime generazioni, da Clinton e Obama fino a Biden, con la miserevole fuga dall’Afghanistan a segnare l’inizio della fine. E che per questo non appare un passaggio reversibile, almeno in tempi brevi, quand’anche Trump uscisse di scena.
Dico tutto ciò con grande sofferenza, avendo sempre creduto e difeso il valore della solidarietà euro-atlantica. Ma proprio per questo credo sia non solo giusto, nel senso di onesto intellettualmente, ma anche e soprattutto necessario, nel senso di utile alla comprensione di ciò che occorre fare in una circostanza così difficile, dire con franchezza che, ci piaccia o no, un ciclo storico è finito. E qui scatta il secondo errore esiziale che si rischia di commettere: attardarsi a negarlo o rimpiangerlo, o peggio a far festa. Viceversa, si devono impegnare tutte le proprie forze nell’individuare e costruire percorsi nuovi. Con lungimiranza e coraggio, senza tabù. Io provo a indicarne quattro.
Il primo è scontato ma fondamentale, perché premessa indispensabile per gli altri tre: la creazione degli Stati Uniti d’Europa. Lo so, non è cosa che si faccia dall’oggi al domani e non basta auspicarla perché si avveri. Ma se per decenni, da Ventotene (do you know?) in poi, è stata una dolce utopia, se con l’euro era diventata una necessità irrealizzata, se con le grandi crisi finanziarie di questo secolo era uno scudo che ci è mancato, ora, dal momento dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia come primo passo per la (ri)costruzione dell’impero sovietico e con l’alleanza atlantica colpita a morte da Trump, l’Europa federale sul modello Usa è diventata un irrinunciabile strumento di sopravvivenza. Basta con le prudenze e le mezze misure, con le lente marce di avvicinamento che non finiscono mai. Le forze autenticamente europeiste – quelle liberaldemocratiche, cattolico-popolari, socialdemocratiche e riformiste – non siano schiave delle alleanze nazionali dove sono collocate e si ritrovino intorno ad una proposta comune, in nome di un’istanza superiore che è diventata un’emergenza. Sarà anche un’ottima occasione per sottoporre quegli accordi politici nazionali ad una sana verifica chiarificatrice.
Il secondo percorso è già stato imboccato, e va sotto il nome di “coalizione dei volenterosi”. Nasce come esigenza militare a difesa dell’Ucraina lasciata sola dagli Stati Uniti, si consolida come gamba non americana della Nato – passaggio indispensabile a fronte della follia trumpiana di voler considerare Putin un interlocutore privilegiato fino al punto di sottomettersi alle sue palesi prese in giro – ma può e deve coltivare un’ambizione di natura geopolitica di valenza più generale: ricostruire l’Occidente perduto, ridisegnandone il perimetro e ridefinendone le regole d’ingaggio e la governance. Non contro gli Stati Uniti, sia chiaro, ma pronti a prescinderne se per loro scelta e responsabilità si chiameranno fuori. Un leader capace di fare da collante e indicare la via già c’è, e si chiama Keir Starmer. Il premier laburista inglese è stato capace, fin qui, di un autentico capolavoro: archiviare la Brexit senza porla in discussione. Si è riavvicinato all’Europa, fino a guidarla con leadership autentica (quella che non ha bisogno di mandati formali), e nello stesso tempo ha mantenuto i migliori rapporti possibili con Trump (nelle condizioni date) senza concedergli nulla. Va incoraggiato e aiutato ad andare avanti, senza gelosie e miseri tentativi di ridimensionare il progetto, anche perché andrà avanti lo stesso e a restare esclusi c’è da rimetterci. Con lui c’è Emmanuel Macron, che tra soli due anni lascerà l’Eliseo, con le presidenziali del 2027, e sarà utile se proverà a mettersi al servizio dell’Europa. C’è qualche italiano che, libero da incarichi e dotato di carisma e autorevolezza, vuol dar loro una mano?
Il terzo percorso che va coraggiosamente costruito è la logica conseguenza dei primi due: congegnare un rapporto equilibrato con la Cina. Partendo dal presupposto che prescinderne è impossibile prima ancora che autolesionistico: perché si tratta del primo pilastro manifatturiero del mondo, perché dei sempre più importanti materiali che vanno sotto il nome di terre rare la Cina controlla a livello globale il 70% dell’estrazione e il 90% della lavorazione, perché Pechino sta rafforzando l’area di libero scambio con i paesi del sud-est asiatico (Asean, nel 2024 rapporti commerciali bilaterali per mille miliardi di dollari) e ha già conquistato larga parte dell’Africa, perché nelle tecnologie più innovative, intelligenza artificiale compresa, se la gioca con gli Stati Uniti. Fin qui con la Cina abbiamo tenuto un atteggiamento schizoide, specie noi italiani, passando dal troppo al niente. Il fatto è che non si può andare in ordine sparso, paese per paese. Allo stesso modo che con gli Stati Uniti, occorre che i rapporti siano definiti e tenuti a livello comunitario. Meglio se da un governo federale, ma nell’attesa, già da ora attraverso la Commissione Ue, mettendo a fattor comune quanto i singoli paesi europei hanno fatto, stanno facendo e vorrebbero fare con Pechino. Si agisca con pragmatismo, lasciando perdere il desiderio di schierarsi, nella guerra Usa-Cina, con una delle due parti in commedia. Certo, ora i ruoli sembrano essersi invertiti: gli Stati Uniti, simbolo del libero mercato e della globalizzazione, si trincerano dietro un protezionismo populista, mentre la Cina comunista assurge al ruolo di paladino dei liberi scambi e del multilateralismo. Ma gli Usa restano una democrazia, anche se ferita dalle tendenze autocratiche di Trump, e l’altro un regime, che Xi Jinping ha reso allo stesso tempo più ferreo e più moderno rispetto ai tempi di piazza Tienanmen. Così la conta dei pregi e dei difetti non aiuta.
Infine, la quarta e ultima ambizione, quella più audace: provare a riaffermare un ordine mondiale dei commerci e delle monete. La mente corre subito alla conferenza di Bretton Woods del 1944, quando a guerra mondiale ancora in corso si definì un sistema monetario internazionale, a guida americana, basato su un nuovo paradigma: non più il “gold standard” ma il “dollar standard”. Quel sistema, che fu alla base dello sviluppo travolgente del commercio internazionale libero e di pagamenti garantiti, ebbe termine nel 1971 quando Nixon decise la fine della convertibilità del dollaro in oro. Ma i principi stabiliti nella cittadina del New Hampshire 27 anni prima – supremazia del dollaro, eletto a moneta di garanzia, e free trade – sono rimasti fino ai giorni nostri. Anzi fino a ieri, perché Trump con la manovra dei dazi – e si badi bene, non solo per le tariffe imposte, ma anche per l’incertezza generata dai suoi stop and go – ha minato sia la credibilità del dollaro che i flussi commerciali, nel fallace convincimento che l’America si sia impoverita per colpa di tutto questo e che il protezionismo sia il mezzo giusto per riportarla “all’età dell’oro” (inteso non solo come ricchezza diffusa ma con sistema ante Bretton Woods). Idea bacata, ma che purtroppo ha prodotto il baco. E non è tale da poterci mettere semplicemente una pezza. Ecco perché sono convinto che sia altamente necessaria una nuova Bretton Woods, o comunque un consesso globale in cui rinegoziare i rapporti valutari e coordinare le politiche monetarie.
Ed è partendo da questa radicata convinzione che mercoledì 16 aprile ho chiamato nella mia War Room tre economisti di vaglia ed esperienza – Marcello Messori, Salvatore Rossi e Giovanni Tria (qui il link) – con questa premessa: abbiamo un anno di tempo, perché a maggio 2026 scade il mandato del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e solo finché c’è lui le grandi banche centrali del mondo possono tentare di mettersi d’accordo nell’intento di arginare la scellerata guerra commerciale in corso e le sue nefaste conseguenze, a cominciare dal disordine monetario. Trump, infatti, se lo sarebbe già tolto dai piedi volentieri, e per questo lo ha ripetutamente dileggiato nella speranza che lasciasse, ma lui ha fatto sapere che rimarrà al suo posto fino all’ultimo giorno. Dopo Powell, però, una delle poche istituzioni capaci di controbilanciare lo strabordante potere della Casa Bianca sarà in mano a Trump. Ecco perché occorre utilizzare l’anno di tempo che resta. Tuttavia, gli ospiti della War Room mi hanno fatto osservare che per una nuova Bretton Woods non bastano i banchieri centrali, ci vogliono i governi, e con Washington messa così non si va da nessuna parte. Vero. Ma dalla discussione sono emerse comunque due considerazioni: comunque vale la pena di proporre il tema, perché c’è bisogno di creare e accumulare consapevolezza; si può e si deve procedere per step. Il primo potrebbe consistere nell’avere le monete digitali delle banche centrali e coordinarle tra loro. Anche per sbarrare la strada alla deriva trumpiana di voler sostituire le divise nazionali con gli stable coin, cioè criptovalute il cui valore è ancorato a un altro asset (per esempio il dollaro o l’oro). Ma stando attenti a non disintermediare le banche, che restano un pilastro fondamentale delle diverse economie. Con il secondo step, poi, si potrebbe recuperare, riadattandola, una vecchia idea di Keynes esposta proprio a Bretton Woods e ricordata da Messori: la creazione di una moneta sovranazionale, che funga da safe asset per tutte le aree economiche, su cui innestare le divise ufficiali delle diverse aree aderenti al patto. Insomma, sostituire il ruolo del dollaro come moneta di riferimento globale con una supermoneta internazionale che dovrebbe essere non fisica ma digitale.
Guardate, cari lettori, che non si tratta di sognare, ma al contrario di avere i piedi ben piantati per terra e gli occhi aperti, perché tutto sta cambiando e in queste circostanze ti tocca scegliere se subire il cambiamento o provare a governarlo. Non so cosa ci sia scritto nel copione del film “incontro con Donald” che avrà per protagonista la Meloni: spero qualcosa che abbia a che fare con la seconda opzione, ma temo sia la solita trama appartenente alla prima. Nell’attesa di vederlo, il film, auguro a tutti noi prima ancora che a lui, che il Presidente Mattarella abbia una pronta guarigione e ritorni ad essere come prima e più di prima la straordinaria sentinella che è della nostra democrazia, così fragile e bisognosa di un clima di concordia e cooperazione. Ne abbiamo un disperato bisogno. Buona Pasqua a tutti. (e.cisnetto@terzarepubblica.it)
L'EDITORIALE
DI TERZA REPUBBLICA
Terza Repubblica è il quotidiano online fondato e diretto da Enrico Cisnetto nato nel 2005 dall'esperienza di Società Aperta con l'obiettivo di creare uno spazio di commento indipendente e fuori dal coro sul contesto politico-economico del paese.