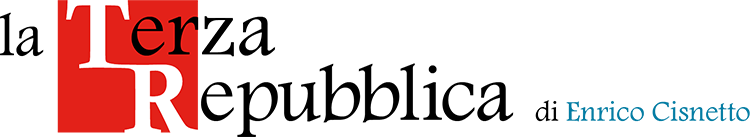Scudo fiscale: i dati non tornano
Casus belli o nervo scoperto?
L’autonomia della Banca centrale esige un diverso confronto da parte delle istituzioni della politicadi Angelo De Mattia - 24 febbraio 2010
Casus belli o nervo scoperto, punctum dolens? E’ bastato che la Banca d’Italia pubblicasse i dati raccolti ed elaborati con la consueta professionalità relativi alle attività rimpatriate o regolarizzate secondo lo scudo fiscale – dati diversi da quelli del Tesoro – perché il Ministro Calderoli lanciasse i suoi fulmini tacciando Bankitalia di essere banca di opposizione e invitandola a ritornare ai suoi doversi istituzionali, come se la pubblicazione dei dati della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l’estero non fosse un suo preciso dovere d’istituto.
Dopo l’ostensione di cifre, quale che sia il fenomeno alle quali si riferiscono, sarebbe legittimo attendersi che chi dissente opponga le cifre a suo parere corrette e chiarisca perché tali sono. E, invece, la reazione è stata quella di un tardo sessantottismo, tacendosi sui numeri e buttando in politica la relativa differenza ( per non dire della dichiarazione del Direttore dell’Agenzia delle entrate su somma e totali dal vago sapore “decurtisiano” ).
La stampa ha dato notizia, con qualche termine improprio, che i capitali interessati dallo scudo secondo Bankitalia sono pari a 85 miliardi, non ai 93 indicati dal Tesoro, e che quelli effettivamente rientrati in Italia sono 35 miliardi. Detta così, è sembrata una rilevazione offensiva a chi sulle sorti magnifiche e progressive dello scudo fiscale aveva puntato, come conseguenza dell’asserita sicura possibilità di impiego in Italia dei capitali rientrati per promuovere lo sviluppo; e ciò soprattutto per tacitare le accuse di aver favorito evasori e riciclatori e di avere leso la certezza del diritto.
Ovviamente, i dati e le spiegazioni sono ben diversi. Innanzitutto, la rilevazione di Palazzo Koch esclude alcuni beni patrimoniali o gli importi al disotto della soglia di rilevazione. Vi è, poi, da considerare che alcune operazioni, per le quali è stata comunque pagata entro il 15 dicembre l’imposta dovuta, potranno essere regolarizzate o rimpatriate entro l’anno in corso, ricorrendo alcune cause ostative che per ora lo hanno impedito. Dunque, occorrerà attendere le pubblicazioni dei dati nei prossimi mesi per un quadro completo e per poter tener conto anche di segnalazioni eventualmente errate o mancanti.
Quanto ai rimpatri, ne esistono due categorie, oltre alla regolarizzazione in senso stretto che comporta il mantenimento all’estero delle attività: i rimpatri giuridici, senza liquidazione, che non comportano il disinvestimento delle attività detenute verso l’estero e quelli con liquidazione che tale disinvestimento presuppongono. Il Tesoro mette in un unico calderone i “ rimpatri” e giunge alla conclusione che essi coprono il 98 per cento delle attività scudate, mentre la Banca d’Italia indica la percentuale del 46 per cento, ma la riferisce ai rimpatri con liquidazione. Questi ultimi, che rappresentano dei flussi, sono registrati nella bilancia dei pagamenti, mentre i rimpatri senza liquidazione e le regolarizzazioni sono registrati nella posizione patrimoniale dell’Italia verso l’estero.
Tutto dovrebbe essere, così, abbastanza chiaro. Naturalmente, la differenza dei concetti di riferimento non è ininfluente circa le conseguenze pratiche a seconda del tipo di rimpatrio e di regolarizzazione e circa gli effetti su eventuali investimenti nel nostro Paese. Dunque, solo fino a un certo punto si può parlare di una tempesta in un bicchiere d’acqua. Sarebbe, allora, legittimo attendersi che il Tesoro, anziché limitarsi di fatto alle accennate dichiarazioni del titolare delle Entrate, chiarisca la propria posizione con numeri e classificazioni, secondo la legge. Dopo che si è giunti gravemente addirittura a porre una sballata questione istituzionale e a richiamare precedenti impropri, come le considerazioni spesso svolte correttamente dalla Banca d’Italia in materia previdenziale, è il minimo che ci si dovrebbe aspettare.
L’insofferenza che emerge quando l’Istituto di Via Nazionale fa parlare i numeri, le analisi e i dati di fatto è indicativa di una singolare concezione della democrazia economica e dei poteri neutri di garanzia nell’assetto tout court democratico. La storia si ripete. L’autonomia e l’indipendenza della Banca centrale – sancite costituzionalmente, dato il rango del Trattato di Maastricht, e vivificate dalla forza intellettuale di chi nella Banca lavora – esigerebbero un ben diverso confronto da parte delle istituzioni della politica. Una dialettica sempre possibile, ovviamente, nel merito contrapponendo analisi e dati solidi se si è capaci, ma mai decampante oltre la specificità dei problemi per investire arrogantemente il ruolo dell’Istituzione.
L’immagine che si offre a livello internazionale in quest’ultimo caso non è certamente esaltante. E, per di più, contrasta con gli stessi apprezzamenti del Presidente del Consiglio.
Dopo l’ostensione di cifre, quale che sia il fenomeno alle quali si riferiscono, sarebbe legittimo attendersi che chi dissente opponga le cifre a suo parere corrette e chiarisca perché tali sono. E, invece, la reazione è stata quella di un tardo sessantottismo, tacendosi sui numeri e buttando in politica la relativa differenza ( per non dire della dichiarazione del Direttore dell’Agenzia delle entrate su somma e totali dal vago sapore “decurtisiano” ).
La stampa ha dato notizia, con qualche termine improprio, che i capitali interessati dallo scudo secondo Bankitalia sono pari a 85 miliardi, non ai 93 indicati dal Tesoro, e che quelli effettivamente rientrati in Italia sono 35 miliardi. Detta così, è sembrata una rilevazione offensiva a chi sulle sorti magnifiche e progressive dello scudo fiscale aveva puntato, come conseguenza dell’asserita sicura possibilità di impiego in Italia dei capitali rientrati per promuovere lo sviluppo; e ciò soprattutto per tacitare le accuse di aver favorito evasori e riciclatori e di avere leso la certezza del diritto.
Ovviamente, i dati e le spiegazioni sono ben diversi. Innanzitutto, la rilevazione di Palazzo Koch esclude alcuni beni patrimoniali o gli importi al disotto della soglia di rilevazione. Vi è, poi, da considerare che alcune operazioni, per le quali è stata comunque pagata entro il 15 dicembre l’imposta dovuta, potranno essere regolarizzate o rimpatriate entro l’anno in corso, ricorrendo alcune cause ostative che per ora lo hanno impedito. Dunque, occorrerà attendere le pubblicazioni dei dati nei prossimi mesi per un quadro completo e per poter tener conto anche di segnalazioni eventualmente errate o mancanti.
Quanto ai rimpatri, ne esistono due categorie, oltre alla regolarizzazione in senso stretto che comporta il mantenimento all’estero delle attività: i rimpatri giuridici, senza liquidazione, che non comportano il disinvestimento delle attività detenute verso l’estero e quelli con liquidazione che tale disinvestimento presuppongono. Il Tesoro mette in un unico calderone i “ rimpatri” e giunge alla conclusione che essi coprono il 98 per cento delle attività scudate, mentre la Banca d’Italia indica la percentuale del 46 per cento, ma la riferisce ai rimpatri con liquidazione. Questi ultimi, che rappresentano dei flussi, sono registrati nella bilancia dei pagamenti, mentre i rimpatri senza liquidazione e le regolarizzazioni sono registrati nella posizione patrimoniale dell’Italia verso l’estero.
Tutto dovrebbe essere, così, abbastanza chiaro. Naturalmente, la differenza dei concetti di riferimento non è ininfluente circa le conseguenze pratiche a seconda del tipo di rimpatrio e di regolarizzazione e circa gli effetti su eventuali investimenti nel nostro Paese. Dunque, solo fino a un certo punto si può parlare di una tempesta in un bicchiere d’acqua. Sarebbe, allora, legittimo attendersi che il Tesoro, anziché limitarsi di fatto alle accennate dichiarazioni del titolare delle Entrate, chiarisca la propria posizione con numeri e classificazioni, secondo la legge. Dopo che si è giunti gravemente addirittura a porre una sballata questione istituzionale e a richiamare precedenti impropri, come le considerazioni spesso svolte correttamente dalla Banca d’Italia in materia previdenziale, è il minimo che ci si dovrebbe aspettare.
L’insofferenza che emerge quando l’Istituto di Via Nazionale fa parlare i numeri, le analisi e i dati di fatto è indicativa di una singolare concezione della democrazia economica e dei poteri neutri di garanzia nell’assetto tout court democratico. La storia si ripete. L’autonomia e l’indipendenza della Banca centrale – sancite costituzionalmente, dato il rango del Trattato di Maastricht, e vivificate dalla forza intellettuale di chi nella Banca lavora – esigerebbero un ben diverso confronto da parte delle istituzioni della politica. Una dialettica sempre possibile, ovviamente, nel merito contrapponendo analisi e dati solidi se si è capaci, ma mai decampante oltre la specificità dei problemi per investire arrogantemente il ruolo dell’Istituzione.
L’immagine che si offre a livello internazionale in quest’ultimo caso non è certamente esaltante. E, per di più, contrasta con gli stessi apprezzamenti del Presidente del Consiglio.
L'EDITORIALE
DI TERZA REPUBBLICA
Terza Repubblica è il quotidiano online fondato e diretto da Enrico Cisnetto nato nel 2005 dall'esperienza di Società Aperta con l'obiettivo di creare uno spazio di commento indipendente e fuori dal coro sul contesto politico-economico del paese.